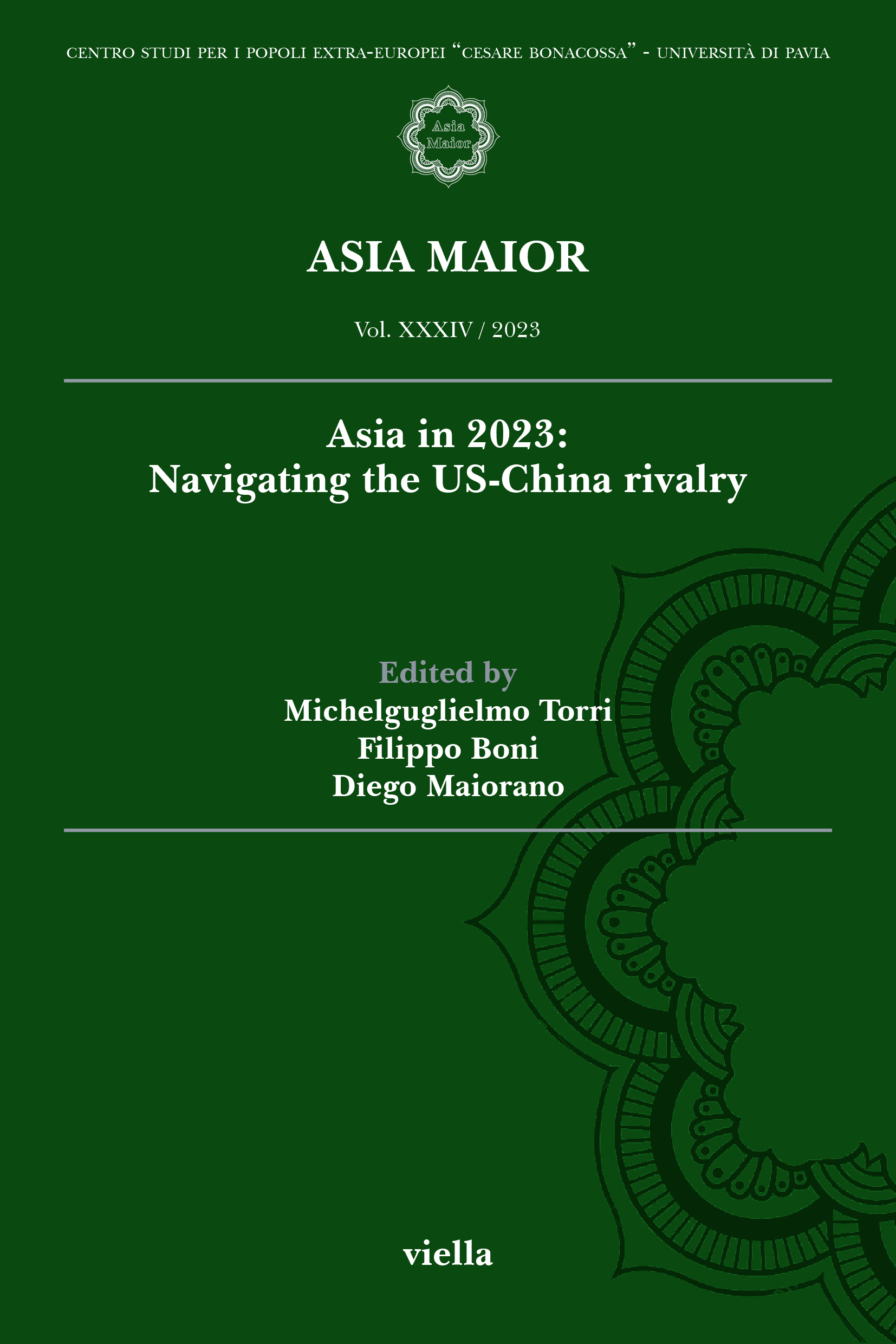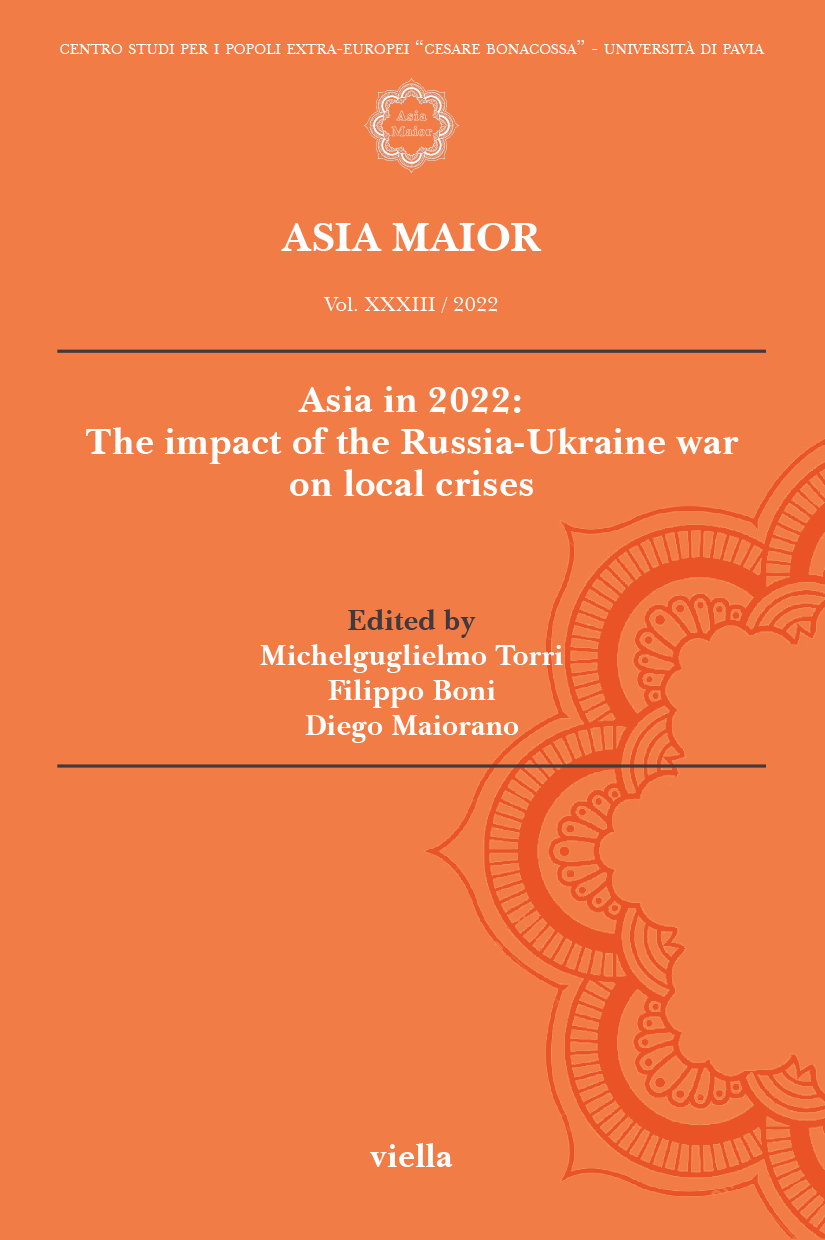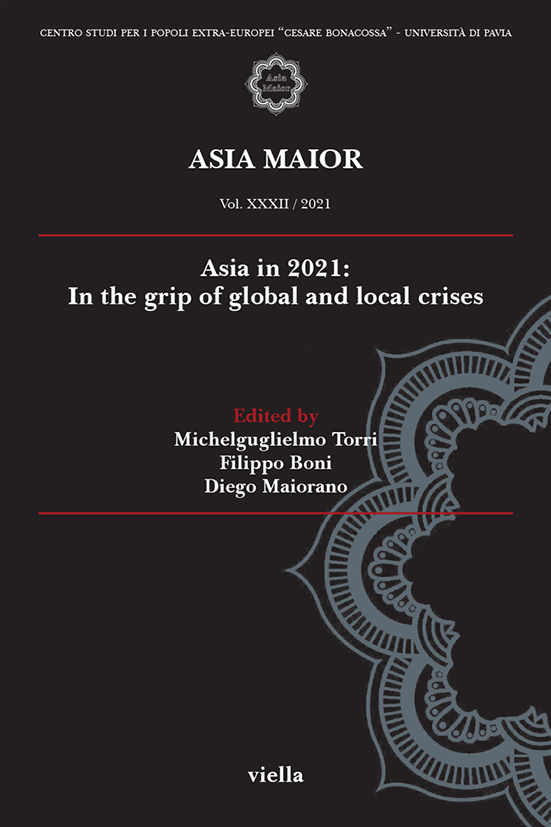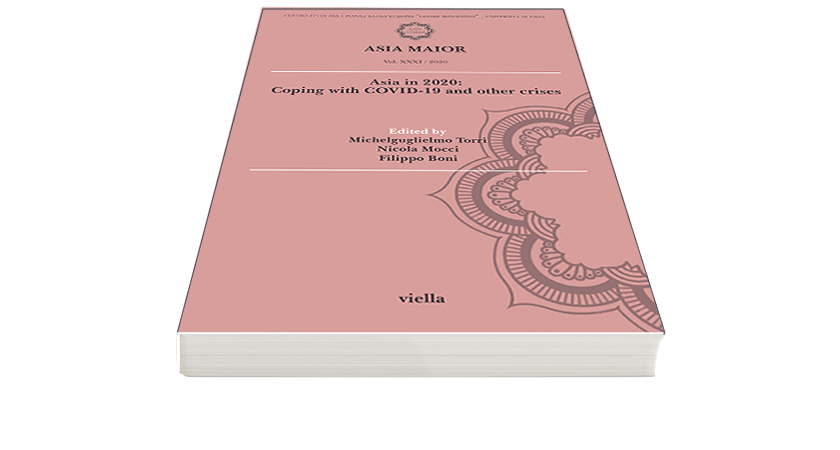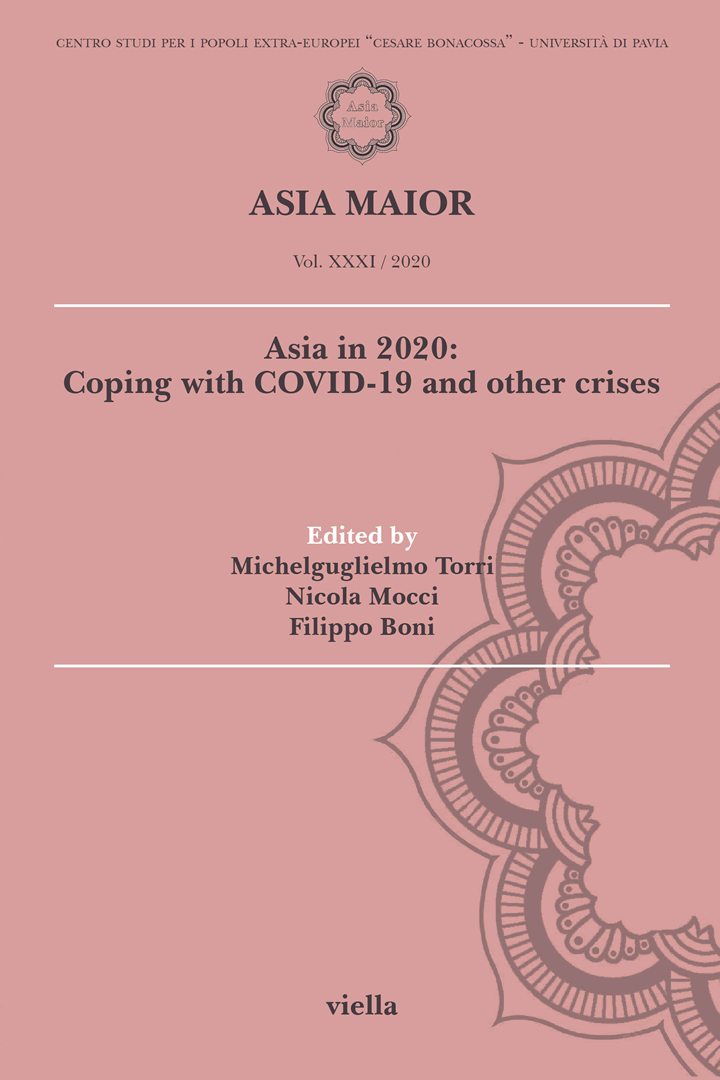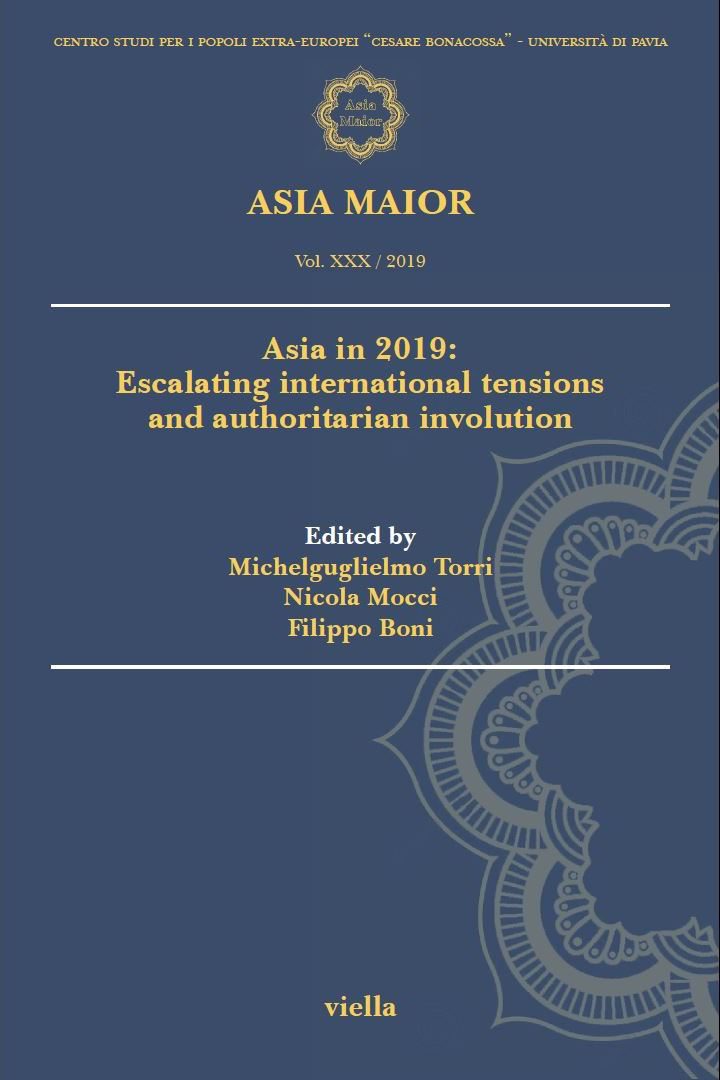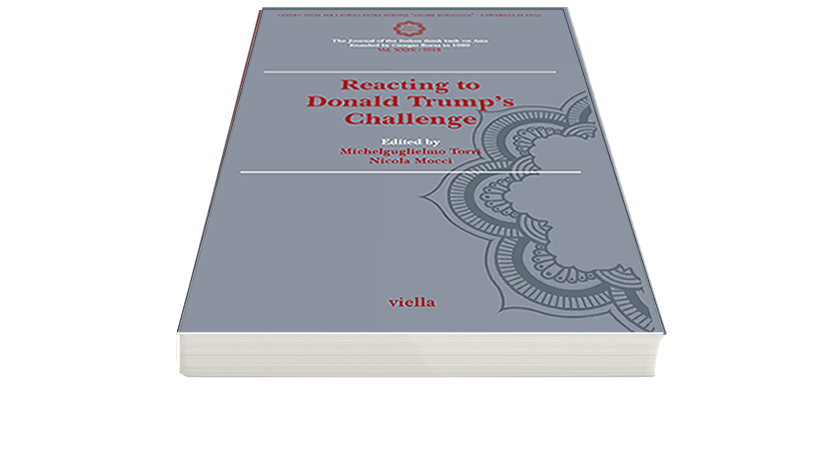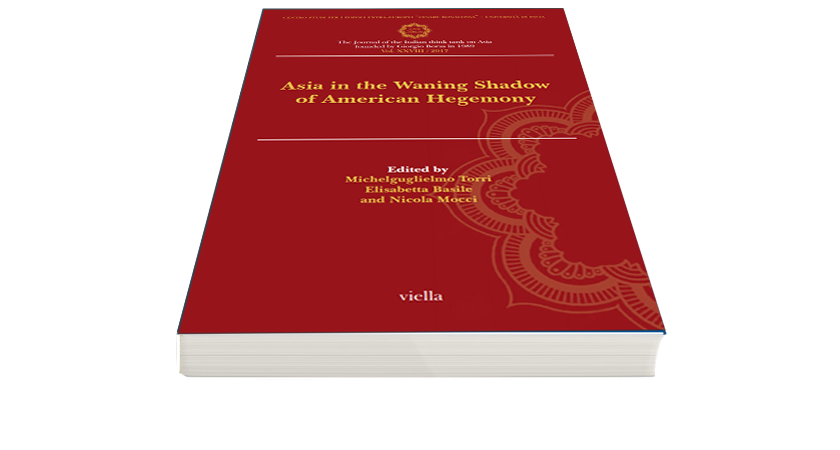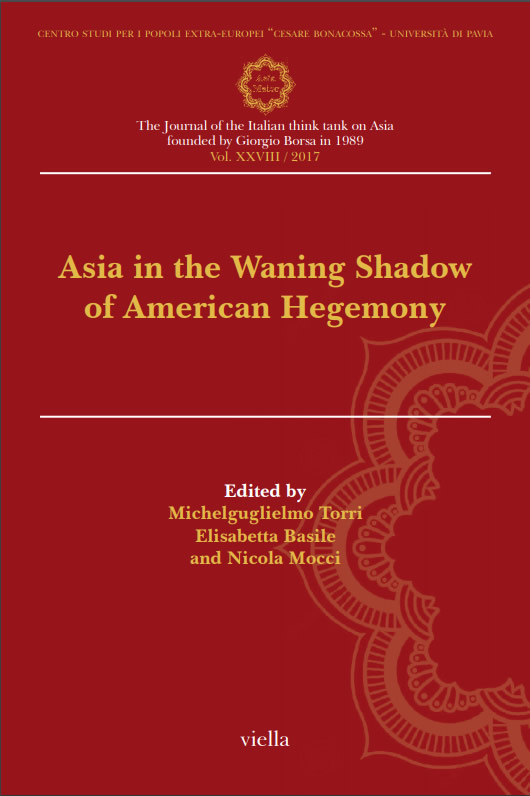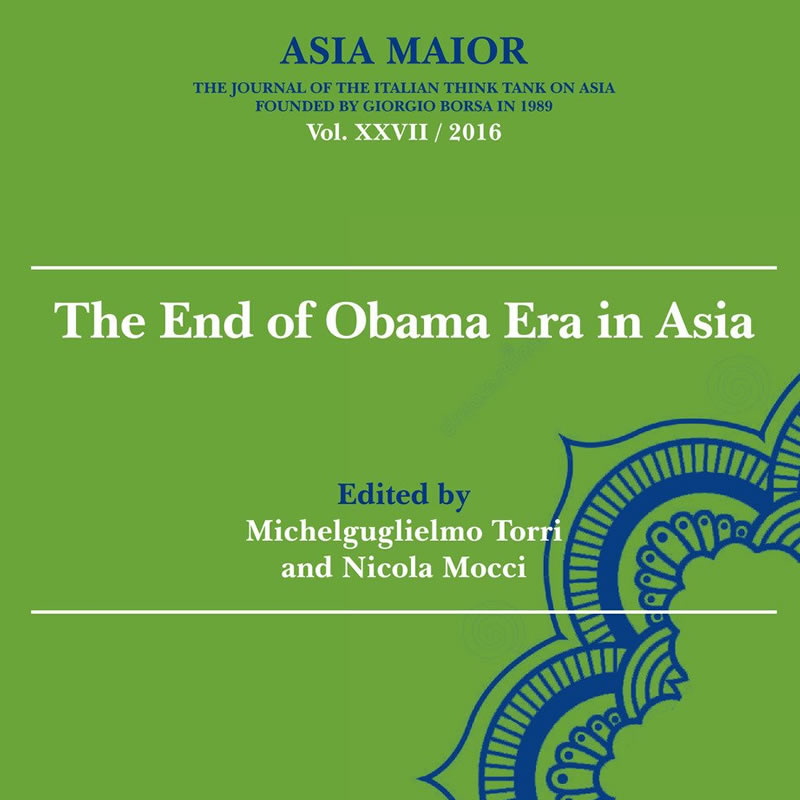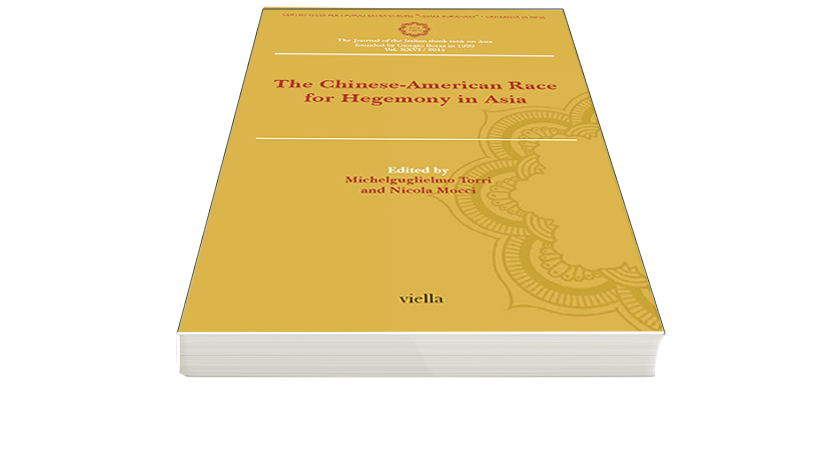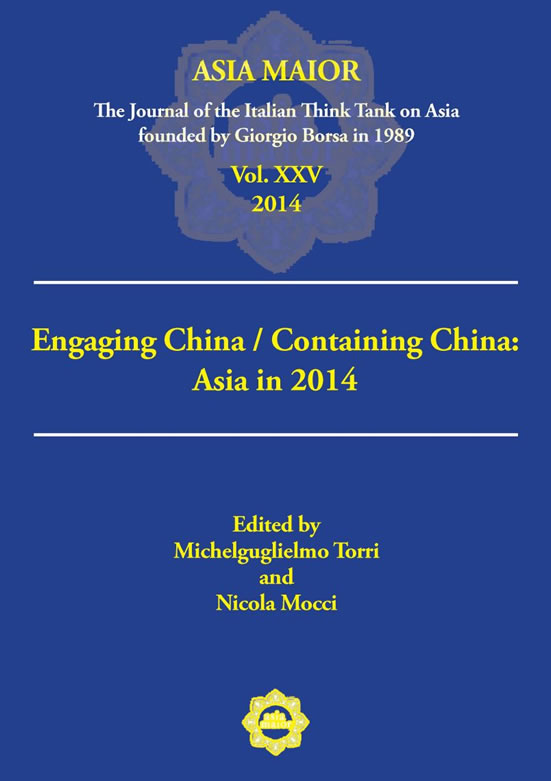Ripresa economica, conflitti sociali e tensioni geopolitiche in Asia
Available also in pdf – Download Pdf
* Desidero ringraziare Michela Cerimele, Francesca Congiu, Barbara Onnis, Sa- brina Perra e Michelguglielmo Torri per i preziosi consigli e per aver commentato e corretto la prima versione di questo scritto. Ovviamente la responsabilità per ogni rimanente imperfezione o errore è solo mia.
1. La ripresa economica in Asia nel 2010
Nel corso del 2010, mentre la gran parte dei paesi occidentali era alla ricerca di soluzioni efficaci per lenire gli effetti della crisi economica scoppiata nel 2008, l’Asia Maior (quella parte dell’Asia delimitata a Nord dal Caucaso e dai confini meridionali della Russia e a Occidente dalla Turchia e dai paesi arabi), ha fatto ulteriori passi da gigante. I paesi asiatici, infatti, hanno trainato la ripresa economica mondiale e hanno consolidato posizioni di primato nei diversi settori della scienza, della tecnologia e della politica.
Per quanto l’indice di crescita del prodotto interno lordo sia oramai un indicatore vetusto e vieppiù inadeguato a misurare la ricchezza degli stati, nel 2010 la regione dell’Asia dell’est ha segnato un incremento medio del PIL del 7,5% rispetto al 2009. In quest’area spiccano la vertiginosa ripresa dell’economia della Cina, con un indice del 10,5%, e quella record di Singapore vicina al 15%. Nell’Asia del sud il tasso medio di crescita è stato del 6%, dato che ha risentito del rallentamento del Pakistan, in seguito ai disastri causati dalle alluvioni e dalle inondazioni, ma dove l’India ha registrato un incremento del 9,7% rispetto al 2009 [IMF 2010, cap. 2]. Anche la macro regione dell’Asia Centrale ha dimostrato di aver iniziato una ripresa economica sostanziale, trainata soprattutto dalla crescita economica della Russia, che costituisce il partner commerciale più importante delle ex repubbliche sovietiche. A questa si sono uniti gli effetti dei provvedimenti di stimolo alla domanda attuati nel 2009 dai governi centroasiatici, oltre alla rendita dell’esportazione delle immense risorse di gas naturale e di petrolio. Spicca, tra questi paesi, l’apice raggiunto dal PIL del Turkmenistan, aumentato del 9,4% rispetto al 2009, e il dato negativo -3,5% del Kirghizistan, dovuto al lungo periodo di conflitti interetnici che, durante il 2010, hanno tenuto il paese in stallo.
Ma ciò che ha sorpreso maggiormente gli analisti è stato il dato clamoroso secondo cui la ricchezza prodotta dalla Cina per la prima volta avrebbe superato quella del Giappone e, di questo passo, nell’arco di una decina di anni, potrebbe sorpassare quella degli Stati Uniti. Il prodotto interno lordo nipponico, infatti, è cresciuto a un tasso annuo di appena il 2,8%, ben al di sotto del 4,4% registrato nel primo trimestre del 2010, per raggiungere nel periodo maggio-settembre un livello assoluto di 1.286 miliardi di dollari, a fronte dei 1.335 miliardi di dollari raggiunti dal PIL cinese nello stesso periodo [W/B 16 agosto 2010, «China GDP Surpasses Japan, Capping Three-Decade Rise»]. Si consideri, inoltre, che il Giappone ha raggiunto anche il record di debito pubblico pari al 200% del PIL e che le previsioni indicano ulteriori aggravamenti [W/EIU 25 ottobre 2010, «Economy: More stimulus»]. Vale la pena ricordare che sulla base dei parametri dell’Unione Europea, un tasso di debito pubblico di queste dimensioni farebbe parlare di pericolo di default, cioè di fallimento del paese.
Il superamento del Giappone da parte della Cina, per quanto prevedibile e atteso, ha suscitato clamore e interesse sia per l’inarrestabile crescita cinese quanto per il continuo declino della potenza nipponica. In realtà, analisti e politici sono interessati a capire le conseguenze che questo declino giapponese avrà nello scacchiere geopolitico mondiale e regionale. Il dato in questione ha rappresentato, infatti, un’ulteriore conferma delle difficoltà politiche della dirigenza della Sinistra nipponica a porre rimedio al ciclo negativo del capitalismo giapponese e alle sue conseguenze sociali.
I fattori che hanno determinato la rapida ripresa economica asiatica sono stati di varia natura. I dati pubblicati dagli istituti di Washington (Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale) e dall’Asian Development Bank hanno indicato un rafforzamento della domanda interna, in tutta la regione asiatica, dovuto in parte alle diffuse agevolazioni fiscali e agli stimoli ai consumi attuati durante il corso del 2009 e del 2010. Il declino nella seconda parte del 2010 e, in particolare, negli ultimi quattro mesi dell’anno, è coinciso, infatti, con l’esaurimento degli incentivi statali, tranne che in Giappone, dove un massiccio piano di sostegno al consumo del valore di 61 miliardi di dollari è continuato fino alla fine del 2010 e i cui effetti si vedranno solo nel 2011 [W/EIU, 25 ottobre 2010 «Economy: More stimulus»].
Oltre alla crescita della domanda interna, la ripresa economica della regione asiatica è stata accompagnata da segnali, seppur deboli, di rivitalizzazione delle esportazioni. Insieme all’aumento dei consumi interni, le esportazioni hanno consentito alle «tigri asiatiche» e alle economie in transizione sia di riportarsi ai livelli di produzione precedenti alla crisi sia di tenere sotto controllo la disoccupazione.
Tuttavia, è apparso evidente come le economie di molti paesi asiatici, con la Cina in prima fila e, a seguire, i paesi dell’ASEAN, abbiano intrapreso dei cambiamenti strutturali nel loro modello di sviluppo. A suscitare maggiore interesse sono stati i provvedimenti di quei paesi che hanno avuto come obiettivo principale la crescita della domanda interna. Ciò dimostra che il modello che ha caratterizzato il sistema industriale produttivo degli ultimi trent’anni delle economie emergenti dell’Asia, orientato quasi esclusivamente all’esportazione, si è rivolto in maniera più massiccia ai consumi interni. Questo processo è dovuto a un insieme di cause esogene e endogene. Nel primo caso, è stato la conseguenza della drastica riduzione delle importazioni da parte delle economie occidentali (America del Nord e Europa) che, a partire dal secondo dopo guerra, ma in modo sistematico a partire dagli anni Settanta, avevano garantito l’assorbimento delle produzioni asiatiche. Si trattava della domanda di beni durevoli a medio-alto contenuto cognitivo, come i prodotti dell’alta tecnologia, che hanno caratterizzato il processo di industrializzazione del Giappone, dei cosiddetti NIC (Newly Industrialized Countries: Corea del sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore) e delle «tigri asiatiche» (Thailandia, Malaysia e Taiwan, a cui recentemente si sono aggiunti il Vietnam e la Cambogia). In effetti, Vietnam e Cambogia erano stati gli ultimi paesi della regione a orientare il proprio modello di sviluppo alla produzione di beni per l’esportazione. Il modello vietnamita e quello cambogiano si distinguevano, tuttavia, da quello degli altri paesi della regione per le produzioni a basso-medio contenuto cognitivo, come quelle del settore tessile.
I fattori endogeni che hanno reso fattibile questo nuovo orientamento, soprattutto in Cina, sono dovuti innanzitutto alla crescita della ricchezza nominale, a una maggiore facilità di accesso al credito della classe operaia, oltre che alle agevolazioni fiscali concesse dallo stato. In realtà, il governo cinese, attraverso il 12° piano quinquennale, annunciato nel novembre 2010, intende riportare i consumi interni ai livelli del 2000, quando la domanda interna era tale da creare il 46% del PIL, mentre con la crisi del 2008-2009 è scesa fino al 35% [W/EIU 18 ottobre 2010, «Central planning 12.0»]. I provvedimenti che il governo ha attuato per raggiungere tali risultati hanno comportato, tra l’altro, l’aumento dei salari minimi e l’assicurazione delle garanzie sociali anche ai lavoratori migranti [W/EIU 11 novembre 2010 «Possibility of wages being increased»].
Non si deve trascurare, inoltre, il fatto che i dati positivi nell’economia cinese insieme a quelli delle cosiddette economie emergenti, come l’India e i NIC, sono il frutto di imponenti programmi di investimento nella cultura e nella ricerca, attuati a partire dalla fine della guerra fredda. I processi di internazionalizzazione delle università cinesi, ad esempio, hanno consentito una crescita del livello della ricerca scientifica e una regionalizzazione della conoscenza. Tali risultati hanno permesso agli istituti cinesi di iniziare un percorso competitivo con i santuari del sapere nord-americani e europei [Pinna 2009]. Appare significativo il fatto che il settore dell’istruzione, insieme a quello della salute, sia stato fra quelli in cui il numero di occupati è cresciuto più di tutti gli altri [W/ILO 2010b, pp. 15- 16; ILO 2009]. Ciò ha consentito a molti paesi asiatici di entrare in possesso di capacità progettuali e di produzione tali che, unite al basso costo del lavoro, hanno consentito di accelerare la transizione del processo industriale verso una fase di terziarizzazione.
Ciò detto, bisogna anche sottolineare che la ripresa economica dell’Asia Maior, nonostante abbia corso su tassi doppi rispetto alla media dell’indice di crescita mondiale, nel corso del 2010 è stata accompagnata da molteplici conflitti sociali. Ciò potrebbe far pensare che la ripresa economica asiatica non sia stata socialmente inclusiva. Tali argomenti verranno approfonditi nei paragrafi seguenti.
2. I conflitti sociali e il lavoro
Per quanto riguarda i conflitti sociali, si è assistito in Asia, durante il corso del 2010, all’emergere di istanze espresse da soggettività eterogenee che hanno interessato il lavoro, la rappresentanza e la rappresentatività politica. In alcuni casi questi fenomeni si sono sovrapposti e hanno interagito l’uno con l’altro.
Il lavoro, in particolare, fin dalla fine della guerra fredda, ha subìto su scala globale le conseguenze peggiori, in termini qualitativi e quantitativi, dovute alla mondializzazione del capitalismo e all’egemonia neoliberista [Vasapollo, Casadio, Petras, Veltmeyer 2004]. La crisi globale degli ultimi anni ha ulteriormente inasprito il conflitto capitale-lavoro e, soprattutto, nelle economie industrializzate asiatiche, lo ha esasperato facendo emergere nuovi conflitti per le classi sociali urbane e nuove porzioni di classi operaie agricole.
Come ha affermato Lazlo Andor, commissario europeo per il Lavoro e gli affari sociali, durante una conferenza tenutasi nel mese di settembre del 2010 a Oslo, organizzata congiuntamente dall’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) e dall’FMI (Fondo monetario internazionale), su scala globale il 2010 è stato l’annus orribilis per la disoccupazione; in mancanza di politiche adeguate, il 2011 lo sarà per la coesione sociale. I dati presentati da Lazlo parlano di 210 milioni di lavoratori senza lavoro, con un aumento di 34 milioni negli ultimi tre anni (il più alto livello mai raggiunto nella storia) e di una situazione in cui oltre l’80% della popolazione mondiale è priva di misure di welfare. Quasi un miliardo e duecentomila persone, pari al 40% della forza lavoro mondiale, non riescono a guadagnare più di due dollari al giorno e, di conseguenza, non sono in grado di sostentare se stesse e le proprie famiglie [W/O].
I paesi dell’Asia Maior si sono discostati da questa tendenza globale e hanno presentato una situazione meno drammatica. Dai dati pubblicati dall’ILO, concernenti il 2010, si scorge nella regione una stabilità nel numero degli occupati e un aumento delle retribuzioni dei lavoratori in media dell’8%, tra i maggiori a livello mondiale (nel triennio 2006-2009 sono cresciute in media del 7%). In Cina i dati ufficiali del «China Yearbook of Statistics», relativi alle retribuzioni (al netto dell’inflazione calcolata sull’indice dei prezzi al consumo dell’FMI), hanno mostrato una serie positiva dal 2007 al 2009 (+13,1% nel 2007, +11,7% nel 2008, +12,8 nel 2009). Tuttavia, è necessario precisare che tali dati si riferiscono ai salari delle industrie statali o delle unità produttive legate allo stato. Infatti, un’indagine pilota del National Bureau of Statistic cinese ha mostrato come i salari del settore privato sono cresciuti solo del 6,6% nel 2009 [ILO 2010, pp. 3-4].
La crisi delle esportazioni e della perdita del lavoro da parte degli operai si è fatta sentire in alcuni paesi di recente industrializzazione meno che in altri. In Vietnam, per esempio, gran parte dei lavoratori licenziati nei distretti industriali ha trovato impiego in altri settori, come quello delle costruzioni, che ha goduto di incentivi da parte dello stato o in quello dell’agricoltura [Manning 2010].
Tuttavia, è bene chiarire che, sebbene la situazione regionale abbia mostrato segnali positivi sia in termini di stabilità dell’occupazione che in termini di aumenti salariali (influenzata dai dati della Cina, che conta più della metà dei lavoratori dell’intera regione), alcuni paesi hanno sofferto più di altri il fenomeno della disoccupazione e della riduzione salariale. In Giappone, per esempio, il tasso di disoccupazione è aumentato dal 4% del 2007 al 5,1 del 2010. Rispetto al 2009, le retribuzioni in Giappone e in Thailandia sono calate del 2%, mentre in Malaysia e nelle Filippine del 4%. Inoltre, i dati su scala regionale degli ultimi 15 anni hanno rappresentato una situazione tale per cui alla crescita economica non è corrisposta un’uniforme crescita salariale. In generale c’è stato, infatti, un aumento delle retribuzioni dei quadri e un abbassamento dei salari relativi ai lavori in cui sono richiesti livelli minimi di istruzione [W/ILO 2010, p. 12].
L’UNDP in uno studio del 2006, precedente quindi alla crisi economica globale, ha dimostrato come la crescita economica dell’Asia abbia determinato un aumento di ricchezza ma non di lavoro e, al contrario, il fenomeno della globalizzazione, intesa come apertura della grande maggioranza dei paesi asiatici della competizione capitalistica, abbia creato ineguaglianze ed esclusione sociale [UNDP 2006]. Si consideri, inoltre, che l’Asia, nonostante i dati in controtendenza rispetto all’andamento dell’economia mondiale, presenta infatti una situazione tale per cui il 35% dei lavoratori appartiene a quella galassia del lavoro non registrato e, di conseguenza non regolato, del cosiddetto lavoro informale [ILO 2010, p. 1].
I dati dell’ILO relativi al 2010 hanno dimostrato come il fenomeno dell’informalità sia oramai diffuso in maniera massiccia anche nelle economie più avanzate dell’Asia, come per esempio il Giappone e i NIC. Questo avviene attraverso due modalità: la prima è rappresentata dall’impiego di lavoratori immigrati da realtà poverissime (Myanmar, Laos, Filippine), ai quali non vengono garantiti i diritti minimi e la sicurezza sociale; la seconda modalità è rappresentata dall’uscita dei lavoratori dalle liste ufficiali, per entrare nel sottoproletariato del «lavoro nero». In Giappone, per esempio, si calcola che i lavoratori stranieri ufficialmente registrati nel settore manufatturiero e nei servizi sociali siano soltanto l’1,5% del totale dei lavoratori, contro il 16,3% degli USA o l’11,8% del Regno Unito. Pertanto è evidente che il paese possiede un’alta percentuale di lavoro sommerso [W/EIU 21 ottobre 2010, «Japan risk: Alert-Risk scenario watch-list»]. L’ufficio regionale dell’ILO di Bangkok aveva stimato nel 2007 un numero di lavoratori pari a 5,3 milioni di immigrati solo nei paesi di Singapore, Malaysia, Brunei e Thailandia, pronti a svolgere i lavori cosiddetti di «3D» (dirty, dangerous, difficult, ovvero sporchi, pericolosi e difficili) [ILO 2007]. Si tratta, inoltre, di realtà in cui la rappresentanza sindacale è fortemente limitata o perfino vietata all’interno delle fabbriche, come nel settore dell’elettronica in Malaysia, e dove la libertà di manifestare o di scioperare non è garantita.
Ora, un quadro di questo genere dimostrerebbe in maniera inconfutabile che i processi della globalizzazione e la recente crisi economica mondiale abbiano contribuito a indebolire i lavoratori e i loro movimenti. L’ipermobilità del capitale produttivo avrebbe creato un fenomeno che la sociologa americana Beverly Silver ha descritto come «gara al ribasso» dei salari e delle garanzie dei lavoratori, con conseguenze sugli stessi lavoratori e sulla sovranità degli stati. Infatti, gli stati che non smantellano le garanzie di welfare o che le rafforzano vengono puniti dal blocco dei flussi di investimenti e a loro vengono preferiti gli stati del Sud del mondo in cui le condizioni di profittabilità sono maggiori [Silver 2004, pp. 4-5].
Tuttavia, come ha dimostrato Silver nel suo studio, l’ipermobilità del capitale e i suoi spostamenti verso il Sud del mondo non lo hanno rafforzato, ma, al contrario, lo hanno indebolito. Il motivo è rappresentato dalla nascita di nuove organizzazioni e di nuovi movimenti operai nei paesi del Sud, impegnati nella lotta per ottenere le garanzie già conquistate dai paesi industrializzati del Nord. Di qui deriva la dimostrazione della teoria di Silver, secondo la quale il conflitto va dove va il capitale. Vale la pena di ricordare che Silver, nel suo studio, ha analizzato i movimenti operai su una serie storica di lungo periodo, attraverso l’utilizzo del prestigioso database del World Labour Group nel quale sono sistematicamente raccolte informazioni su oltre un secolo di lotte operaie, censendo oltre 90.000 episodi in 168 paesi a partire dalle notizie apparse sulla stampa quotidiana.
Attraverso una ricognizione dei conflitti sociali che hanno coinvolto i movimenti dei lavoratori in Asia, di cui Asia Maior si è fatta sempre interprete, emerge come, negli ultimi anni di crisi globale e in particolare nel 2010, ci sia stata una rinascita e, in alcuni casi, una vera e propria nascita del tentativo, da parte dei lavoratori asiatici, di riunire le proprie forze. Basti pensare alle lotte dei movimenti dei lavoratori del settore tessile in Cambogia o in Bangladesh, che hanno preso vita e forza a partire dalla metà degli anni zero del 2000, in un contesto di repressione sindacale. Nonostante che decenni di egemonia neoliberista abbiano riportato inconfutabili successi negativi in termini di decomposizione e delegittimazione delle forme istituzionali del movimento operaio e della lotta di classe organizzata, in Asia, nei paesi di nuova industrializzazione, sembra che ci siano stati dei fenomeni in controtendenza con l’emergere di nuovi antagonismi organizzati che sono ripartiti dalle fabbriche.
Nella maggior parte dei casi si è trattato di lotte settoriali e difensive che, come in Occidente, si sono polverizzate in una moltitudine eterogenea di gruppi e di richieste. Tuttavia, a differenza dei paesi occidentali, gli antagonismi asiatici in alcuni casi sono riusciti a dare origine a movimenti unitari – anche se non trasnazionali – e, soprattutto, sono riusciti a ottenere miglioramenti delle condizioni contrattuali e aumenti salariali.
Si è trattato di lotte di classe, che hanno coinvolto i lavoratori di tutti i settori del ciclo produttivo. Oltre gli operai delle fabbriche, tuttavia, sono scese in piazza anche alcune categorie di lavoratori che manifestavano per la prima volta (piloti aerei, medici, docenti universitari); si è trattato di un chiaro segno che il conflitto capitale-lavoro, durante la crisi globale in atto, si è acuito e non ha risparmiato nessuno. Tuttavia, i risultati positivi raggiunti, attraverso queste lotte, sembrerebbe testimoniare che in Asia il rapporto di forze fra capitale e lavoro si stia spostando a favore del secondo.
A parte il caso quasi unico di Singapore, in cui non si verifica uno sciopero da oramai 15 anni, l’elenco delle manifestazioni e delle soggettività coinvolte in Asia è lunghissimo. Si darà conto, qui di seguito, delle più significative, in termini di risultati raggiunti, tenendo presente che nella maggior parte dei casi non si è trattato di azioni estemporanee ma di azioni di lotta che trovano le radici nel periodo precedente alla crisi economica globale e sono maturate nel 2010. È interessante ricordare, fra tutti, gli scioperi degli operai delle fabbriche automobilistiche cinesi, nei distretti produttivi nella provincia del Guandong, nel delta del Fiume delle Perle, e di Shenzhen, tristemente noto per i molteplici casi di suicidi fra i lavoratori.
Di questi fenomeni, che si ripetono da anni, ci offre un’analisi dettagliata sia dal punto di vista teorico che analitico, in questo volume, il saggio sulla Cina di Francesca Congiu.
Come si è già visto in precedenza, sono apparsi sorprendenti gli aumenti salariali e il miglioramento delle condizioni contrattuali che gli operai cinesi sono riusciti ad ottenere dalle fabbriche. Si tratta di risultati che hanno seguìto l’altro grande successo, ottenuto a partire dal 2008, della nuova legge sul lavoro, che ha esteso in buona misura i diritti dei lavoratori e ha limitato le prerogative della direzione aziendale. Tale provvedimento ha dato anche nuovo impulso alla militanza di base, tanto che gli scioperi del 2010 nascevano dal basso e non trovavano sponda nel sindacato ufficiale cinese. Questo era in- fatti considerato più assertivo nei confronti delle aziende di quanto non lo fosse con gli operai [Chang, Silver 2008; Franceschini, Tom- ba 2010; W/EIU 8 Novembre 2010, «China – Labour market risk»].
In Malaysia, in cui le relazioni industriali sono caratterizzate da forti limitazioni all’attività sindacale, il congresso nazionale dei sindacati che si è tenuto nel mese di maggio ha approvato la formazione di comitati di base (non interni all’azienda, perché vietati) nel settore dell’elettronica. Gli operai dell’hi-tech, infatti, potevano essere rappresentati solo dai delegati regionali e, in ogni caso, solo nella penisola e non nella parte insulare del paese. In pratica gli operai potevano contare solo su tre rappresentanti per 286.000 lavoratori iscritti al Department of Trade Union Affairs, l’istituto che sovraintende i sindacati [W/EIU 6 gennaio 2011 «Malaysia risk: Labour market risk»].
Nei distretti del tessile, dell’abbigliamento e delle calzature della Cambogia, del Bangladesh, del Vietnam, durante il 2010, si sono ripetuti scioperi e manifestazioni che hanno coinvolto decine di migliaia di lavoratori per sostenere la richiesta di migliori condizioni contrattuali e di aumenti salariali. I lavoratori delle fabbriche di abbigliamento bengalesi, nonostante le ripetute repressioni violente subìte da parte della polizia, sono riusciti ad ottenere un aumento del salario minimo mensile, raggiungendo i 32,7 euro, per 13 ore di lavoro giornaliere (equivalenti a 1,20 euro al giorno) [W/WS 24 di- cembre 2010, «Another police attack on Bangladeshi garment workers»]. In Cambogia, lo sciopero di tre giorni di 200.000 operai del tessile, nel settembre 2010, ha permesso ai lavoratori di ottenere un aumento del salario mensile minimo da 37,7 a 46 euro. Vale la pena ricordare che in Vietnam il salario minimo per gli operai del settore tessile è di 67,9 euro, in Indonesia di 91,3 e in India di 101,8. Sempre in Bangladesh, un migliaio di minatori delle cave di carbone, dopo l’astensione dal lavoro per pochi giorni, hanno ottenuto dai titolari delle concessioni (due società cinesi) aumenti retributivi del 22% rispetto al 2009 [W/R 27 marzo 2010, «Striking coal miners in Bangladesh return to work»].
L’India, nel 2010, è stata attraversata da una miriade di conflitti sociali. Oltre alla forte tensione creata dalle rivendicazioni violente dei naxaliti e la drammatica situazione dei suicidi dei contadini, come illustrato da Michelguglielmo Torri nelle pagine dedicate all’India in questo e nei precedenti volumi di Asia Maior, i governi locali indiani hanno dovuto far fronte ad una una serie di lotte dei lavoratori. Tra questi, i guidatori di rikshaw nello stato del Maharashstra che hanno chiesto il riconoscimento al governo del loro lavoro come pubblica utilità oltre al taglio della tassa del 12,5% per chilometro percorso, imposta nel maggio 2009. Gli operai delle telecomunicazioni dello stato dell’Andra Pradesh e quelli dell’elettricità del Punjab per mesi hanno protestato contro la privatizzazione delle aziende di stato e il conseguente ridimensionamento della forza lavoro [W/WS 11 dicembre 2010, «India: Punjab power workers strike»].
Accanto a queste rivendicazioni, ci sono state quelle dei lavoratori indiani che, tradizionalmente, sono sempre stati considerati «privilegiati». Nel mese di dicembre, per esempio, gli insegnanti universitari dell’Uttar Pradesh e di Mumbai hanno protestato per ottenere aumenti salariali, e per gli stessi motivi hanno manifestato gli impiegati bancari nel Tamil Nadu e nell’Andhra Pradesh. In Pakistan, dove gli scioperi o le manifestazioni dei lavoratori sono molto rare, sono stati i medici a protestare contro la legge del 2009 meglio nota come Health Care Commission Bill, che ha determinato un peggioramento contrattuale [W/WS 24 dicembre 2010, «Andhra Pradesh, health workers protest»], mentre nello Sri Lanka i medici hanno chiesto nuove assunzioni per alleggerire il carico di lavoro e per poter usufruire dei periodi di ferie [W/WS 24 dicembre 2010, «Sri Lankan doctors strike»].
Nelle Filippine, il personale di terra della compagnia di bandiera della Philippines Airlines, nel mese di dicembre, ha bloccato i voli per protestare contro il taglio di 3.000 lavoratori, in seguito alla privatizzazione dei servizi. Il neo presidente Aquino ha precettato gli impiegati.
Questa rassegna termina con le lotte in quei paesi, come il Giappone e la Corea del sud, che si differenziano dagli altri paesi della regione per la presenza di una struttura industriale avanzata. A Tokyo gli assistenti di volo della Japan Airlines hanno scioperato contro i pensionamenti forzati degli ultracinquantenni. L’azienda, nel mese di agosto, infatti, aveva presentato un piano industriale che, per evitare il fallimento, ha previsto il taglio di 16.000 lavoratori [W/WS 24 dicembre 2010, «Japan Airlines cabin crew to strike»]. Quello della Japan Airlines è solo uno degli esempi dei numerosi casi di precarizzazione del lavoro in Giappone. In parlamento, durante il 2010 si è discusso di quali provvedimenti attuare per rendere il lavoro più flessibile e per consentire alle aziende di licenziare con maggiore facilità i lavoratori.
In Corea del sud, durante l’anno in esame, i sindacati sono rimasti in attesa di verificare le riforme legislative che il governo vorrebbe attuare per rendere il lavoro più flessibile [W/EIU 17 dicembre 2010, «South Korea risk: Labour market risk»]. Gli operai impiegati nella fabbrica di automobili Hyundai hanno scioperato per chiedere la stabilizzazione di 8.200 lavoratori temporanei (il 22% della forza lavoro della casa produttrice), mentre negli stabilimenti della Kia Motors le maestranze sono rimaste per settimane in agitazione contro il taglio da parte dell’azienda del numero di rappresentanti sindacali (Kia intende passare da 137 membri a 18) [W/AP Asia Pulse 30 giugno 2010, «South Korea, labour unrest looms as Kia motors cuts unionized staff»]. Solo una parte degli operai, circa 270, dell’altra casa produttrice di automobili coreana, Ssayong, in amministrazione controllata dal 2009, dopo mesi di scioperi ha ripreso le attività nei mesi estivi [W/D 15 giugno 2010, «Ssangyong Workers Return After 16-month Leave»].
Chiudiamo con una delle vicende più significative verificatasi a Hong Kong, dove la compagnia aerea Cathay Pacific, a fronte di un utile netto annunciato per il 2010 di 1,6 miliardi di dollari, non ha voluto adeguare i salari dei piloti, che rimangono fermi dal 2002. Con la richiesta di aumenti salariali, i piloti hanno minacciato lo sciopero nel mese di dicembre [W/WS, 24 dicembre 2010, «Hong Kong pilots’ union suspends industrial action»].
La sociologa statunitense Silver aveva predetto che se il passato poteva servirci come indicazione per il futuro, allora ci saremmo dovuti attendere l’emergere di movimenti operai forti e militanti in Cina. E puntualmente si sta verificando, oltre che in Cina, anche in Cambogia, in Vietnam e in Bangladesh, dove già nel corso degli ultimi anni si è assistito a fenomeni di ampia sindacalizzazione e unitarietà della classe operaia nelle azioni rivendicative. La teoria di Silver secondo cui il conflitto va dove va il capitale, agli occhi di coloro che ritengono che il movimento operaio globale sia in una fase agonizzante, appare del tutto illusoria. Si tratta di una valutazione che, a parere di chi scrive, non considera le capacità rigenerative della classe operaia attraverso nuove forme e nuove strutture. Ora, appare evidente come la struttura dell’organizzazione post taylorista, che sta emergendo nelle periferie della delocalizzazione asiatica della produzione occidentale, abbia portato all’organizzazione della produzione sul modello del just in time, il sistema secondo il quale si fabbricano i beni sulla base della richiesta del mercato. In sostanza, si tratta di una produzione sul momento, che impone una flessibilità estrema agli operai sia nell’impiego del tempo di lavoro, sia nelle mansioni. Sulla base degli studi di Silver, questo modo di produzione paradossalmente riesce a garantire un potere maggiore ai lavoratori, nel momento in cui essi acquisiscono la consapevolezza della loro insostituibilità. Un eventuale blocco della filiera in time da parte delle forze produttive, infatti, è in grado di sospendere il processo trasnazionale di fabbricazione di un prodotto. Le conseguenze per il capitale, in termini di costi, diventerebbero nel breve periodo insostenibili. Senza trascurare il fatto che una classe operaia ribelle scoraggia ulteriori investimenti esteri e di conseguenza danneggia l’élite capitalista al potere. L’élite verrebbe danneggiata per due ordini di motivi: dal punto di vista economico rischierebbe la riduzione degli investimenti esteri e dal punto di vista politico sarebbe soggetta all’erosione del consenso dovuto all’inasprimento della conflittualità nelle relazioni industriali. In questa situazione, i lavoratori si ritrovano tra le mani una forza contrattuale simile a quella della categoria dei lavoratori dei servizi di trasporto (portuali, ferrovieri, piloti), capace cioè di bloccare un sistema paese.
In Asia, in particolare, la recente crisi economica ha prodotto nuove fasi di lotta di classe, con il concomitante antagonismo di nuove lotte organizzate attorno alle differenze di status (per esempio, etnia, genere, nazionalità) che mirano a creare speciali protezioni per gruppi specifici di lavoratori, con l’esclusione degli altri. L’immigrazione di massa, che ha contribuito e continua a contribuire in modo decisivo alla composizione della classe operaia asiatica, ha portato alla creazione di subalternità che hanno dovuto scontrarsi con fenomeni di razzismo e di emarginazione all’interno della stessa classe operaia. Uno degli esempi più ricorrenti è rappresentato dalle lavoratrici donne che, in Asia, soffrono grandi disparità di salario nei confronti del genere maschile.
3. Il ritorno degli USA in Asia Orientale e l’inasprirsi delle tensioni con la Cina
Nell’ambito delle relazioni internazionali e della diplomazia, il 2010 è stato caratterizzato dalle rivelazioni del sito internet WikiLeaks. A partire dall’autunno 2010, infatti, è iniziata la pubblicazione online di 250.000 cablogrammi della diplomazia degli Stati Uniti. Si trattava di una corposa serie di documenti, molti dei quali segreti o riservati, proveniente dalle ambasciate statunitensi sparse in tutto il mondo. I dispacci trattavano gli argomenti più diversi e, soprattutto, facevano riferimento a fatti recenti e attuali. Tra questi, hanno suscitato molto clamore sui media internazionali quelli che rivelavano i segreti della guerra in corso in Afghanistan, il numero dei civili uccisi dalle forze alleate e le difficoltà degli Stati Uniti a trovare una via d’uscita dal pantano afgano. Altri documenti hanno avuto un impatto internazionale più blando ma, a livello locale, hanno svelato trame politiche segrete che hanno destabilizzato più di un governo. In definitiva, le rivelazioni di WikiLeaks sono state un avvenimento che ha destato forti tensioni tra le diplomazie di tutto il mondo, non solo per gli argomenti trattati, ma anche per la sciatteria dimostrata dagli USA nella protezione dei dati sensibili.
La pubblicazione dei cablogrammi di WikiLeaks arrivava durante una fase del 2010 in cui gli Stati Uniti erano impegnati, in Asia, su diversi fronti diplomatici. Innanzitutto sul fronte afgano che, alle soglie dell’anniversario del decimo anno di conflitto, non segnava risultati positivi in termini di pacificazione del territorio. Al contrario, le elezioni nazionali che si sono svolte durante la primavera del 2010, come descritto da Diego Abenante nel saggio dedicato all’Afghanistan, hanno dimostrato l’assoluta incapacità delle forze locali di trovare soluzioni politiche al conflitto e di garantire una transizione pacifica verso l’autonomia di governo.
L’altro elemento di tensione che ha coinvolto gli USA in Asia è stata la questione della proliferazione nucleare, sia sul fronte nord-coreano sia sul fronte iraniano. Nel primo caso erano state le tensioni nella penisola coreana a spingere Washington a riportare la flotta statunitense nel Mar Giallo a sostegno degli alleati giapponesi e sud-coreani, anche se ufficialmente si trattava della partecipazione ad esercitazioni militari congiunte. Nel secondo caso erano stati i programmi di arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran a coinvolgere gli USA in azioni diplomatiche e mediatiche di contenimento e di isolamento del nemico. Infatti, da un lato gli Stati Uniti hanno scatenato una guerra mediatica contro il regime autoritario di Teheran per la violazione dei diritti umani, strumentalizzando il caso di Sakineh, una donna condannata alla lapidazione per uxoricidio. Dall’altro, si sono impegnati a esercitare pressioni diplomatiche per distogliere il Brasile e la Turchia, dal loro proposito di cooperare con Teheran nei programmi di sviluppo delle tecnologie nucleari. Nel contempo, l’amministrazione Obama ha dovuto convincere la Cina e la Russia ad appoggiare le nuove sanzioni dell’ONU nei confronti dell’Iran.
L’ultimo fronte in cui gli USA si sono impegnati in Asia è stato quello del Mar Cinese Meridionale, uno scacchiere che avevano trascurato da decenni. Nel mese di luglio, infatti, faceva clamore la dichiarazione del segretario di stato Hillary Clinton secondo cui era «interesse ‘nazionale’ degli USA sostenere un processo di collaborazione diplomatica con tutti i paesi che reclamano la sovranità sulle isole del Mar Meridionale della Cina per risolvere le dispute territoriali senza l’uso della forza». E, con una velata minaccia alla Cina, il segretario di stato americano ha aggiunto: «Gli Stati Uniti si opporranno all’uso della minaccia della forza di ogni contendente».
In questo modo gli USA ritornavano, dopo anni di assenza, in maniera impetuosa in uno scenario asiatico che coinvolgeva sia i paesi del Nord, con riferimento alla questione nord-coreana, sia quelli del Sud, nella disputa della sovranità degli arcipelaghi, degli isolotti e degli scogli affioranti nel Mar Meridionale della Cina. Tale questione, peraltro, è diventata sempre più spinosa da quando sono stati scoperti giacimenti petroliferi nei fondali sottomarini, motivo per cui la definizione della sovranità offrirebbe la possibilità di gestire importanti risorse energetiche.
In realtà, in tale contesto, le dichiarazioni del segretario di stato americano, sopra riportate, possono essere viste come parte non solo di un rinnovato attivismo americano nel Mar Cinese Meridionale, ma come parte di una politica più ampia, deliberatamente aggressiva nei confronti dalla Cina. Di tale politica sono stati parte integrante la vendita di armi americane a Taiwan; l’incontro di Obama con il Dalai Lama; le critiche a Pechino per non aver fatto pressioni nei confronti della Corea del nord sulla questione della proliferazione nucleare; le esercitazioni della flotta statunitense al largo delle coste cinesi; il ritorno, dopo decenni, di una portaerei a poche miglia da Shanghai; e, per finire, la legge protezionista approvata dal Congresso statunitense che tassa del 40% quei prodotti cinesi che avrebbero goduto dei vantaggi della moneta cinese, il cui valore è considerato troppo basso (cioè, in pratica, una legge rivolta contro tutti i prodotti esportati dalla Cina!).
In sostanza appare chiaro che gli USA hanno voluto mettere in gioco quel poco della riserva di egemonia di cui ancora godono per iniziare una strategia di indebolimento e di contenimento della Cina. Questo ha portato al repentino inasprimento, nel 2010, di quelle che, nel periodo precedente, erano state le posizioni ufficiali degli USA nei confronti della Cina. Posizioni, come ricordato da Francesca Congiu in questo volume, che erano state caratterizzate da una fase di relativa distensione.
La nuova strategia americana di durezza nei confronti di Pechino, ha trovato riscontro ed è stata rafforzata dall’atteggiamento dei grandi organi di stampa occidentali. Incalzati dai media statunitensi, che hanno trovato sponda nel Fondo Monetario internazionale, nella Banca Mondiale e nell’Unione Europea, gli organi di stampa occidentali continuano da anni a seguire nei confronti della Cina una doppia strategia di delegittimazione. Da un lato mettono in luce e accentuano le limitazioni e i difetti della Cina e, dall’altro lato, «costruiscono» ed enfatizzano l’atteggiamento minaccioso che, secondo le loro analisi, caratterizzerebbe il comportamento della Cina nei confronti degli stati vicini e dell’Occidente.
In sostanza, quindi, l’atteggiamento della stampa occidentale nei confronti del grande paese asiatico è oramai caratterizzato da una decennale ostilità e dalla diffidenza pregiudiziale. Ne sono esempio, negli anni passati, le polemiche che hanno preceduto i giochi olimpici di Pechino, con le predizioni di un loro fallimento; le accuse pregiudiziali dell’incapacità da parte cinese di organizzare manifestazioni di tale portata; l’enfasi data ai tentativi di boicottaggio della marcia della fiaccola olimpica. Più recentemente gli organi di stampa occidentale hanno dato spazio al pericolo che in Cina possa scoppiare un’enorme bolla immobiliare; all’inflazione cinese (descritta come in una fase di aumento incontrollato); alla crescita troppo rapida dell’economia cinese; al supposto indebitamento eccessivo delle banche cinesi (additato come un elemento che spingeva il sistema finanziario verso il baratro); alla dimensione «coloniale» degli investimenti cinesi oltreoceano, in particolare in Africa; allo squilibrio dell’economia cinese, troppo legata all’esportazione e non al consumo interno; e, soprattutto, all’eccessiva competitività delle esportazioni cinesi (additata come uno dei fattori principali di squilibrio negli affari globali).
Come documentato da Francesca Congiu in un seminario tenutosi nel novembre 2010 [Congiu 2010], anche l’Italia – duole dirlo – ha partecipato a quella che è diventa una sistematica mistificazione della realtà cinese.
L’obiettivo, secondo l’emerito sociologo statunitense James Petras, è quello di incolpare la Cina delle debolezze e del declino della competitività economica statunitense nel mondo [Petras 2010]. Sempre secondo Petras, tale atteggiamento, facendo leva sulla questione dei diritti umani, mira ad influenzare e ad esercitare pressioni sui cinesi affinché cambino le loro politiche. L’obiettivo degli USA, in pratica, è quello di costruirsi strumenti di ricatto nei confronti della Cina da utilizzare anche nelle altre questioni chiave: quelle nucleari in Iran e nella Corea del nord. Si tratta infatti di delegittimare e mettere in difficoltà la Cina sul piano internazionale per convincerla ad approvare le sanzioni nei confronti dell’Iran e per indurla ad abbandonare il sostegno politico e finanziario al regime di Kim Jong-il.
Tale campagna, inoltre, mira a rafforzare il tentativo delle élite politiche e finanziarie di Washington e di New York, in corso da anni, di fare pressioni su Pechino affinché deregolamenti il settore finanziario e faciliti la scalata dei mercati finanziari cinesi da parte del capitale americano [Petras 2010]. Inoltre, al fine di creare una cultura della speculazione finanziaria, gli Stati Uniti hanno incoraggiato gli investitori oltreoceano e i fondi di investimento a sovranità cinese a investire nel mercato di Wall Street per creare un collegamento con le società finanziarie statunitensi. È un modo questo per indebolire la produzione di capitale nell’apparato di pianificazione statale cinese [Petras 2010].
È necessario, a questo punto chiedersi perché mai non ci sia stata una reazione forte a queste provocazioni statunitensi da parte della Cina. Al di là delle manifestazioni di disappunto degli uomini di governo cinesi, la risposta a tale quesito la offre Zhang Yongjin, il direttore del Centre of East Asian Studies dell’Università di Bristol. In un recente saggio del 2007, Zhang affermava che le provocazioni e le minacce degli Stati Uniti, che si ripetono da anni, hanno avuto come conseguenza quella di rafforzare la consapevolezza della potenza cinese [Zhang 2007]. La Cina non ha reagito, se non in maniera blanda, né in passato né nel 2010, perché questa immagine che le viene attribuita di «stato pericoloso o minaccioso» le farebbe comodo.
Questo atteggiamento discende soprattutto dal modo di concepire la sicurezza da parte dei cinesi e va inquadrato nelle trasformazioni sia del sistema internazionale sia dello stato cinese nel periodo successivo alla fine della guerra fredda. Tale periodo è stato caratterizzato a livello internazionale dalla fine del bipolarismo e dall’emergere degli USA come unica superpotenza e, a livello interno, non solo dalla rapida e sostenuta crescita economica del paese, ma anche dal cambiamento dello stato da potere rivoluzionario a stato riformista.
Attraverso la presa d’atto di questa nuova identità di stato nazione, in un contesto internazionale profondamente mutato, rispetto a quello scaturito dalla fine della seconda guerra mondiale, in Cina sono cambiate anche le priorità della sicurezza per il governo. Si ha in questo caso una trasformazione che Zhang ha ben riassunto come «passaggio dall’internazionalismo rivoluzionario al nazionalismo conservativo» [Zhang 2007, p. 169].
La fine del bipolarismo e il rafforzamento delle relazioni con gli Stati Uniti ha determinato, per la Cina, una certa tranquillità sulle frontiere. Il venir meno del potere dell’Unione Sovietica ha determinato il venir meno delle potenziali minacce da parte della Russia e di quella che, dal 1971, era stata l’alleata chiave dell’URSS in Asia, cioè l’India. Ciò ha consentito a Pechino di occuparsi della sua situazione interna, concentrando le sue attenzioni sull’unità e sulla stabilità dello stato nazione. Ma, a rendere insicuro lo stato cinese dal punto di vista internazionale vi è stata la crescita d’importanza dei cosiddetti elementi di non traditional security discourses. Si tratta, cioè, di minacce alla sicurezza che non provengono da organizzazioni militari statali, ma da problematiche socio-politiche (fra cui i disastri naturali, le pandemie, le migrazioni di massa, la pirateria ecc.) e le minacce militari potenziali di attori non statali. Da questo punto di vista è significativo come la nascita della SCO (Shanghai Cooperation Organization), che unisce la Cina alla Russia e a quattro repubbliche centroasiatiche, per Pechino sia ufficialmente legata alla lotta al terrorismo, al separatismo e all’estremismo.
In questo scenario, lo stato nazione della Cina è più interessato a mantenere buoni rapporti commerciali con gli USA e con i vicini partner asiatici, piuttosto che impegnarsi in guerre di posizione o di logoramento geostrategico. Fermo restando il fatto che la Cina parte da posizioni di vantaggio sul piano finanziario. Da un lato, infatti, tiene in mano le redini dell’economia statunitense con il finanziamento dello stato americano attraverso l’acquisto dei buoni del tesoro di Washington (tendenza, peraltro, in diminuzione nel 2010 del 4,3%, da 929 miliardi di dollari a 829 miliardi) [W/T «Major foreign holders of treasury securities»]. Dall’altra gode dei vantaggi degli investimenti diretti delle imprese statunitensi nel territorio cinese, che da anni sono in crescita.
In un rapporto dell’istituto Asian American Studies Center (A-ASC) dell’Università della California del 2009, si legge che nel 2006 gli investimenti diretti della Cina negli USA ammontavano a 600 milioni di dollari, mentre quelli degli USA in Cina erano pari a 22,2 miliardi di dollari. Sulla base di tali dati, i relatori del’AASC hanno commentato: «Le lamentele dei politici e degli investitori statunitensi riguardo al fatto che la Cina possa investire nelle aziende statunitensi con una relativa facilità, mentre mantiene un accesso ristretto al proprio mercato, sembrano non essere confermate dai numeri» [W/AASC].
Dall’altra, la Cina ha iniziato a godere degli enormi vantaggi economici e politici dell’accordo CAFTA (China ASEAN Free Trade Area), che, dal 1° gennaio 2010, ha dato vita all’area di libero scambio più grande del mondo (inizialmente ha coinvolto la Cina e sei paesi dell’ASEAN – Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia – e, dal 2015, includerà anche Vietnam, Cambogia, Laos e Myanmar).
Nonostante le tensioni crescenti tra USA e Cina non sorprenderebbe ritrovare i loro leader in «armonia», il prossimo 19 gennaio 2011 a Washington, in occasione del prossimo incontro bilaterale in programma tra Obama e Hu Jintao, pronti a suggellare nuove intese economiche.
Riferimenti bibliografici
W/AP «Asia Pulse» (http://www.asiapulse.com).
W/B «Bloomberg News» (http://www.businessweek.com.html).
W/D «The Dong-a Ilbo» (http://english.donga.com).
W/O «Oslo Conference» (http://www.osloconference2010.org).
W/R «Reuters» (http://www.reuters.com).
W/WS «World Socialist Web Site» (http://www.wsws.org).
W/AASC «Asian America Studies Center» Foreign Direct Investments (http://www.aasc.ucla.edu/uschina/trade_investment.shtml).
W/T «Treasury of US Government» (http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/ Documents/mfh.txt).
Congiu, Francesca
2010 Cina: crescita economica e autoritarismo. Seminario tenuto presso la Fondazione Luca Raggio. Cagliari, 3 novembre.
Franceschini, Ivan e Luigi Tomba
2010 OffiCina: come cambia il mercato del lavoro, Aspenia, n° 50, pp. 66-74.
ILO «International Labour Organization»
2007 Visions for Asia’s Decent Work Decade: Growth and Jobs to 2015, and background paper Rolling back informality, Asian Regional Forum on Growth, Employment and Decent Work, Pechino, 13-15 Agosto 2007 (http://www.ilo.org).
2009 Impact of the Global Economic Recession on Education (http://www.ilo.org).
2010 Global Wage Report 2010/11: Wage policies in times of crisis (http://www.ilo.org).
2010a Jobs recovery, sectoral coverage, working paper (http://www.ilo.org).
IMF «International Monetary Found»
2010 World economic outlook: Recovery, Risk, and Rebalancing, ottobre (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo).
Lu Zhang e Beverly Silver
2008 Cina: l’epicentro emergente del conflitto operaio mondiale?, in Sacchetto Devi e Massimiliano Tomba (eds.), La lunga accumulazione originaria, Ombre corte, Verona, pp.177-189.
Manning, Chris
2010 Globalization and Labour Markets in Boom and Crisis: the Case of Vietnam, «ASEAN Economic Bulletin», vol. 27, n° 1.
Pinna, Cristina
2009 EU-China relations in higher education: building bridges in global cultural dialogue, «Asia Europe Journal», ottobre, pp. 505-527.
Silver, Beverly
2004 Le forze del lavoro, Bruno Mondadori, Milano.
«United Nations Development Programme»
2006 Asia-Pacific Human development Report 2006: Trade on Human Terms, Colombo.
Vasapollo, Luciano, Mauro Casadio, James Petras e Henry Veltmeyer
2004 Competizione globale. Imperialismi e movimenti di resistenza, Jaca Book, Milano.
Zhang, Yongjing
2007 Discourses of security in China: towards a critical turn?, in Burke, Anthony e Matt McDonald (eds), Critical security in the Asia Pacific, Manchester University Press, Manchester, pp. 167-183.