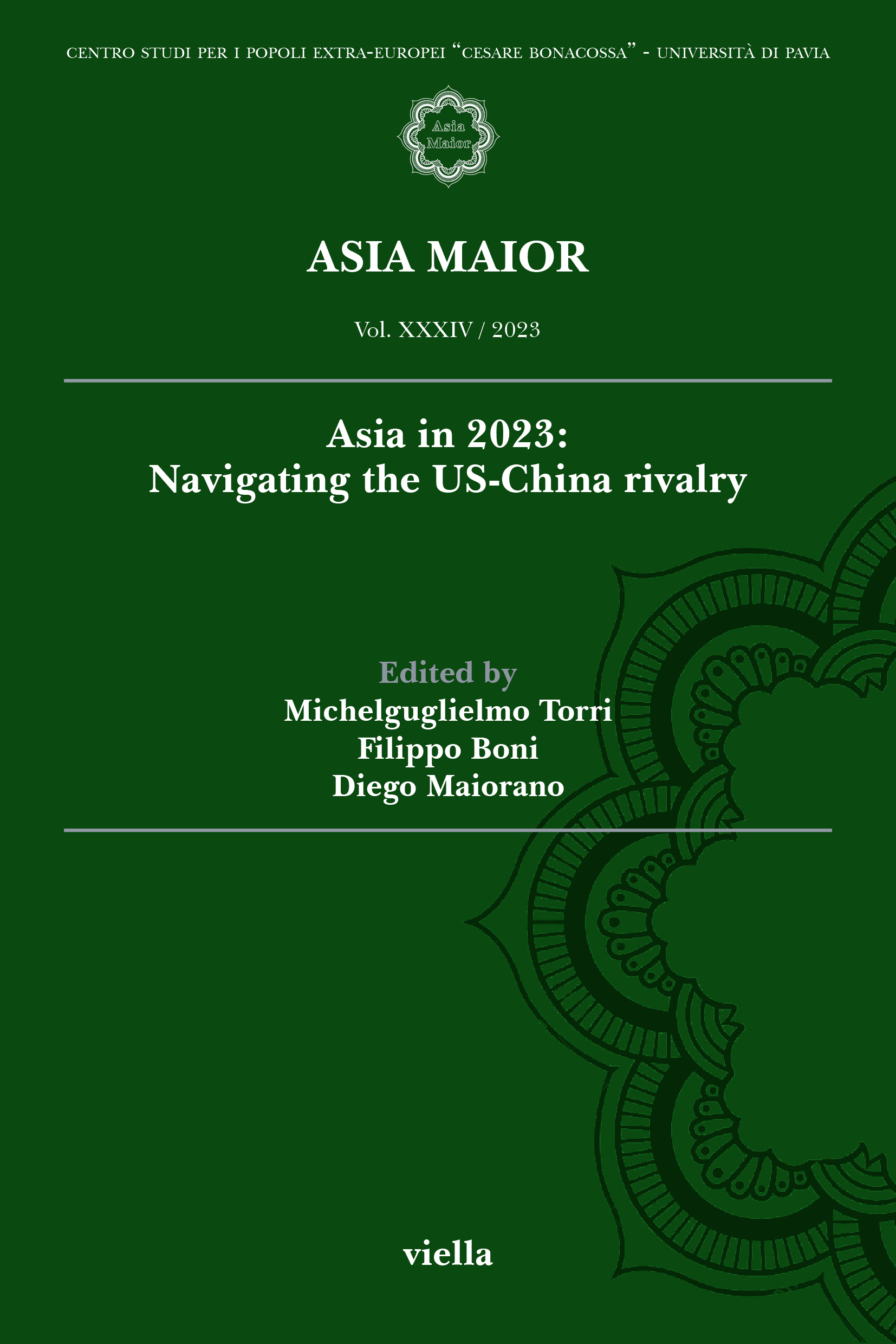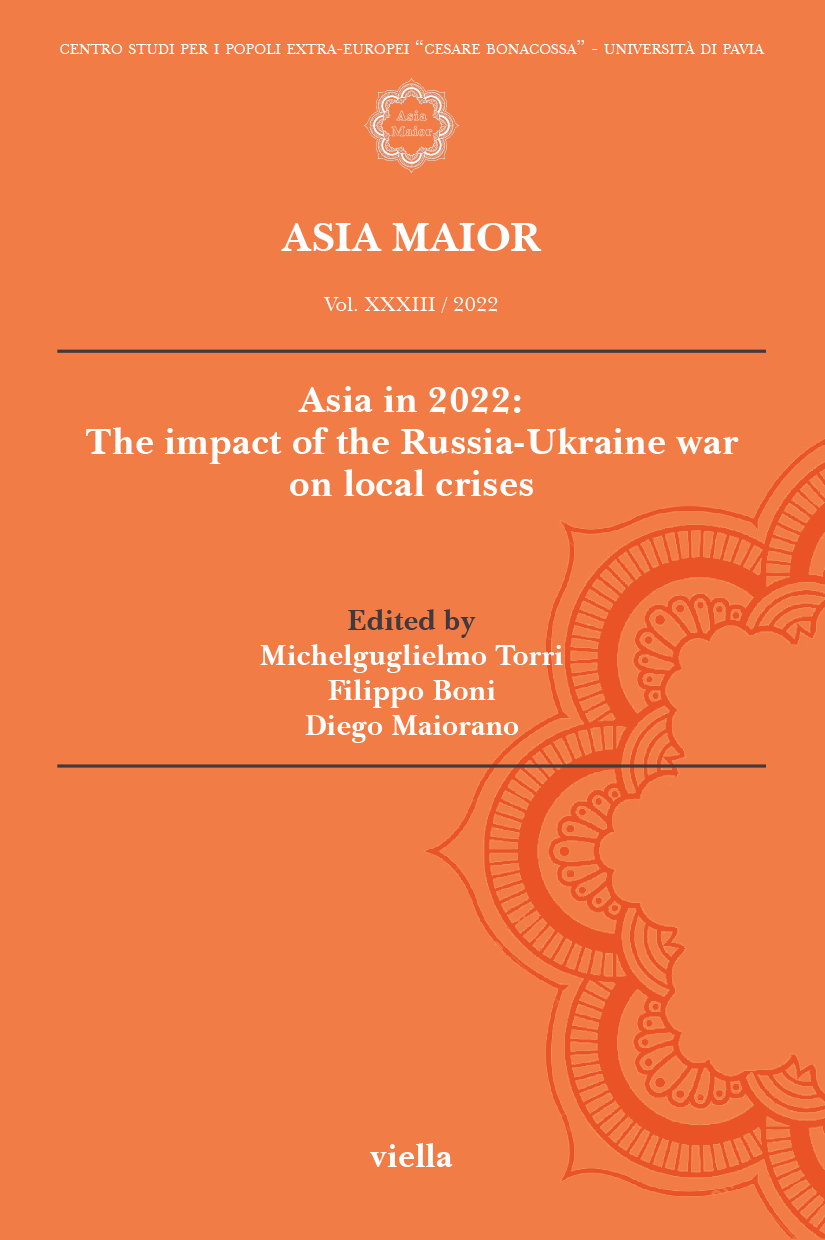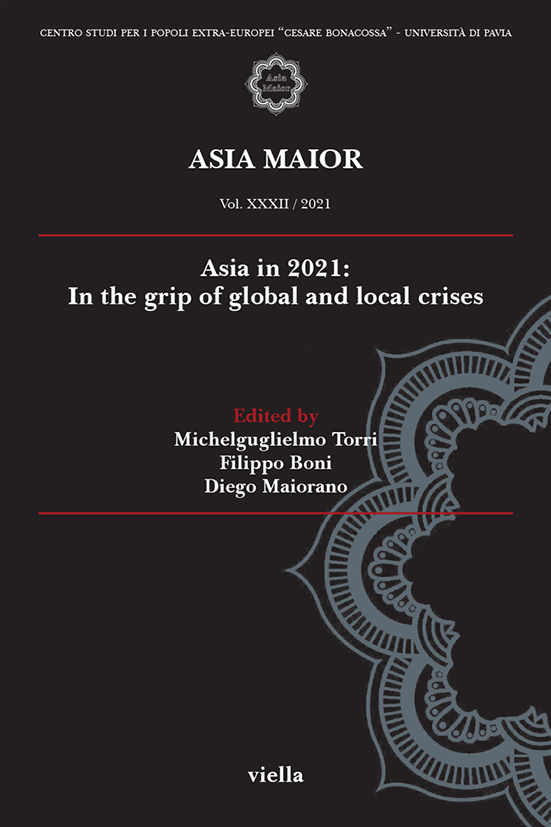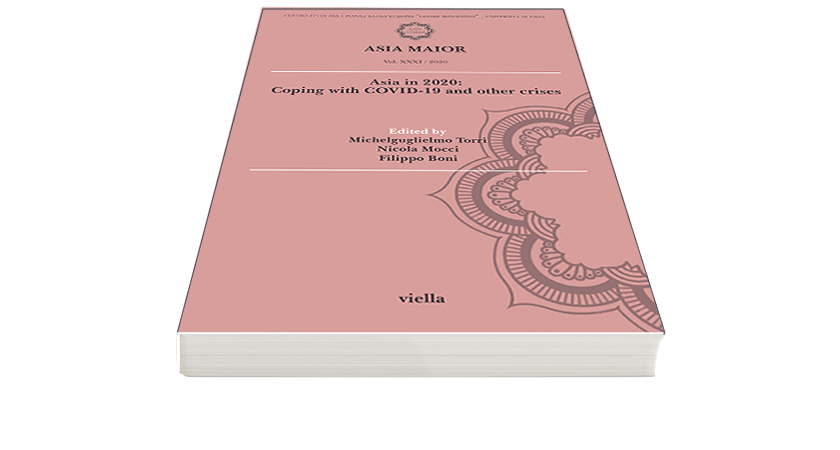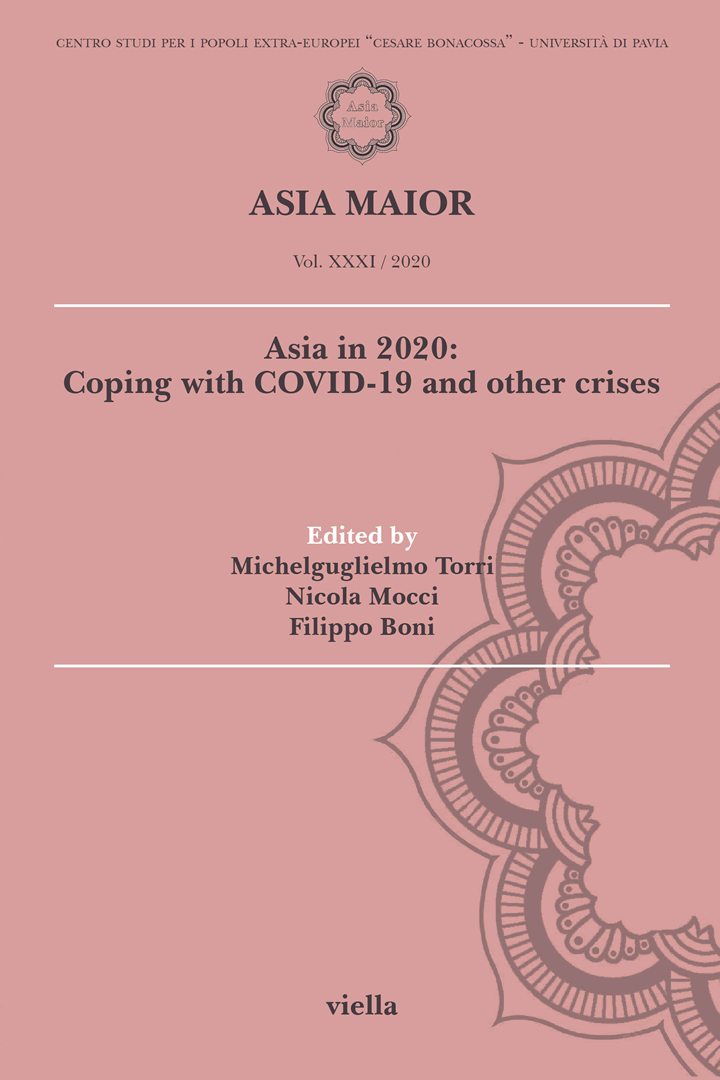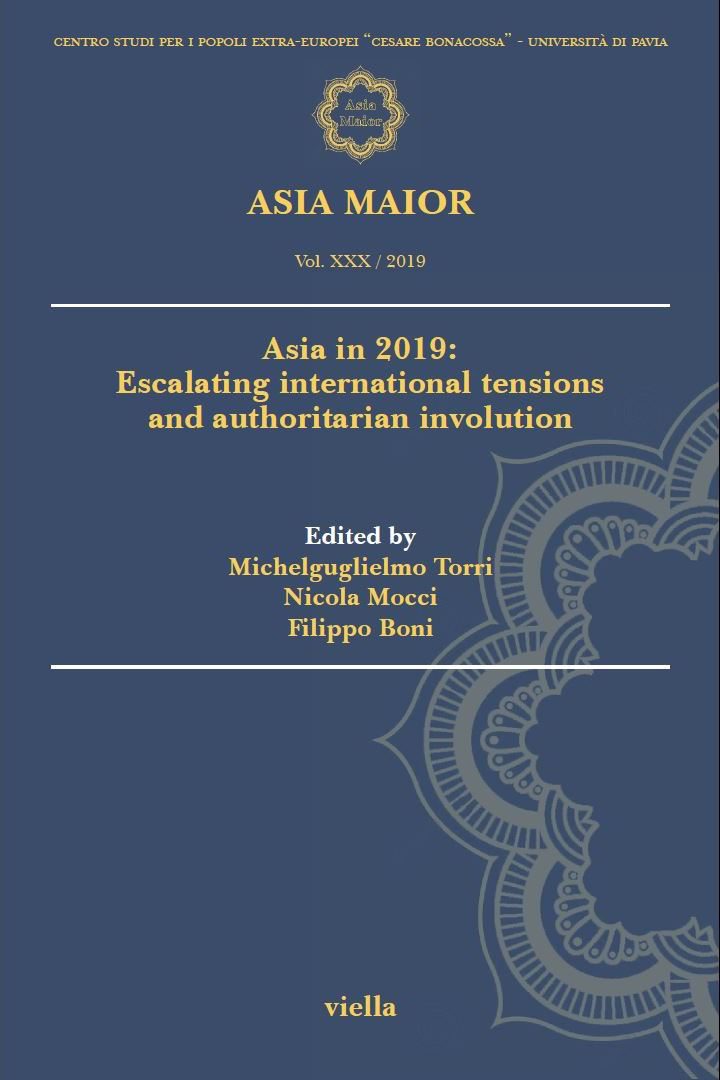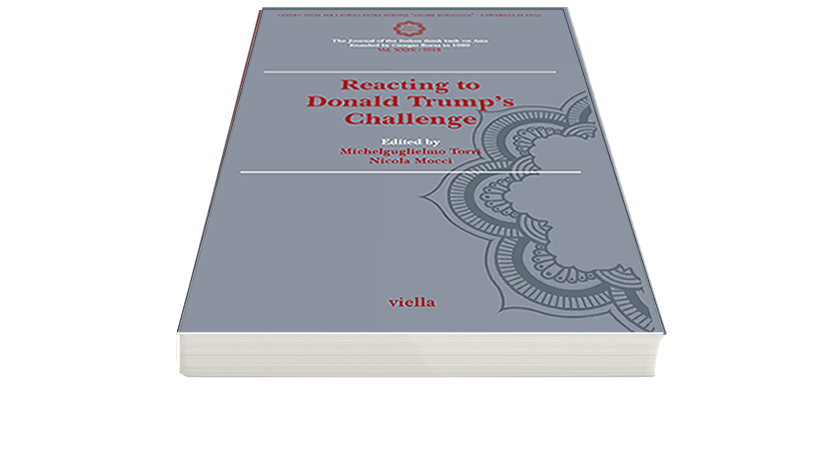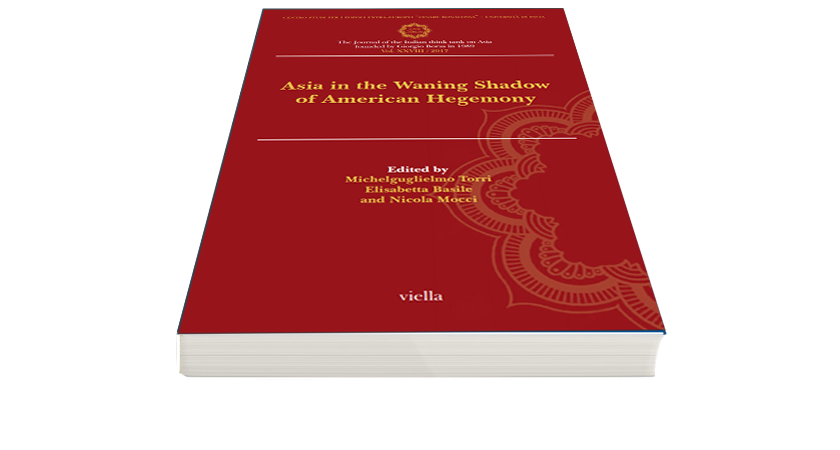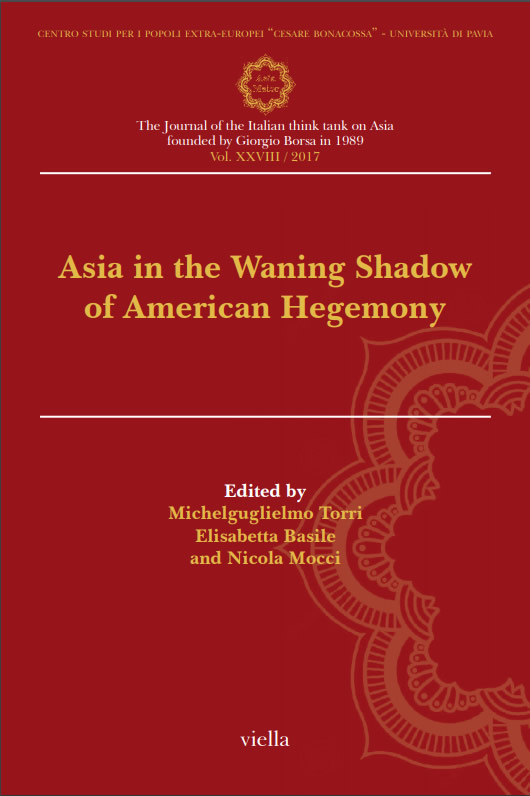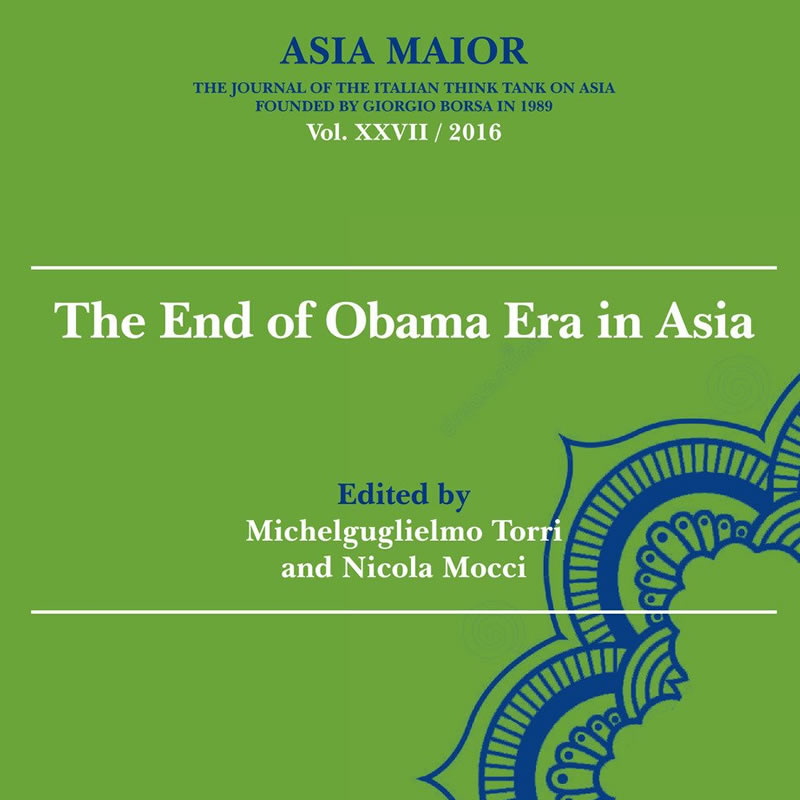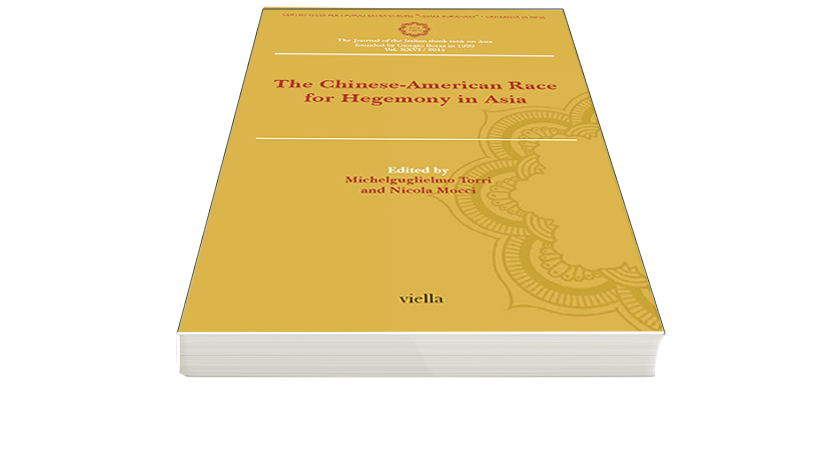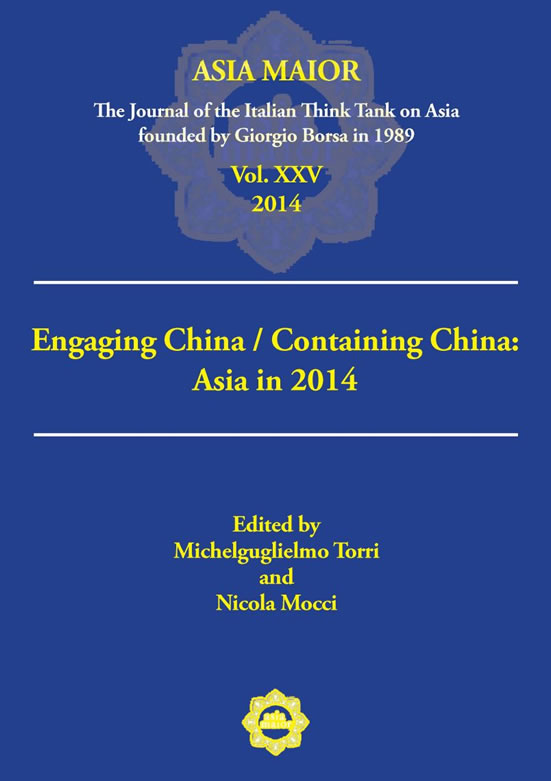Cina: lavoro al centro
Available also in pdf – Download Pdf
1. Tra conflitto sociale e conflitti geopolitici
Nel corso del 2010 il processo di modernizzazione in atto nella Cina popolare dava l’avvio ad una fase fondamentale che ha avuto come centro nevralgico le questioni legate al mondo del lavoro nel settore industriale [AM 2009, pp. 223-26]. Si è trattato dell’avvio di un processo di miglioramento dei livelli salariali e di rinnovamento delle relazioni industriali e delle forme di rappresentanza che è partito dal basso. Infatti, gli scioperi utilizzati come strumento di lotta sono stati organizzati fuori dai perimetri delle singole fabbriche e senza il coinvolgimento del sindacato ufficiale. Era certamente un percorso molto fragile. La convergenza di interessi fra la politica ed il mondo degli affari e la dura competizione economica fra governi locali – determinata dall’autonomismo politico ed amministrativo realizzato oramai da tempo – rendevano più che mai complesso il processo di emancipazione in atto. [AM 2007, pp. 323-27].
La nomina di Xi Jinping alla vice presidenza della commissione militare centrale del partito, avvenuta in occasione del 5° plenum del XVII congresso del PCC (partito comunista cinese), il 15-18 ottobre, faceva pensare ad un orientamento politico ben preciso, diretto alla protezione e al sostegno dell’economia privata e delle aree costiere industrializzate [AM 2007, pp. 319-21]. Infatti, secondo il modello di successione politica, oramai divenuto una pratica istituzionalizzata, questa nomina lo rendeva molto probabilmente il candidato favorito alla successione di Hu Jintao nelle cariche di segretario generale del PCC e di presidente della Repubblica Popolare Cinese (RPC) [Miller 2010, §§1-2]. Tali nomine sarebbero avvenute rispettivamente nel 2012, in seno al XVIII congresso del partito, e nel 2013 in seno all’Assemblea nazionale del popolo. Xi, per usare le parole del noto politologo ed esperto di politica interna cinese Cheng Li, è un «amico del mercato» sia in quanto favorevole ad una politica economica liberista sia nel senso più letterale del termine, in quanto figura politica estremamente popolare nel mondo degli affari cinese. La sua carriera si era, infatti, costruita intorno alle zone economiche speciali e si pensava che avrebbe verosimilmente promosso una politica economica favorevole alla nuova classe media imprenditoriale della dinamica Cina costiera. Tuttavia, lo stesso Cheng Li ammetteva che il potere di Xi avrebbe dovuto essere necessariamente controbilanciato dal gruppo politico più vicino a Hu Jintao, schieratosi in più occasioni a favore di politiche ridistributive [Cheng Li 2010; AM 2007, pp. 313-19]. Un governo così articolato incarnava, in sostanza, un progetto politico a lungo termine di ristrutturazione del modello di sviluppo finora fondato su un modello di industrializzazione orientata alle esportazioni e sulla strategia dell’uso del basso costo del lavoro quale vantaggio nazionale competitivo. Spinta anche dalla crisi economica internazionale, la dirigenza di Hu Jintao e di Wen Jiabao, attraverso l’approvazione della proposta relativa al 12° piano quinquennale (2011-2015), poneva le basi per una transizione verso un’industrializzazione tesa a soddisfare la domanda interna, che si auspicava crescente e che, comunque, ci si impegnava a sostenere.
Proprio l’esigenza di un ridimensionamento delle diseguaglianze economiche e sociali, condizione imprescindibile anche per lo sviluppo della domanda interna, apriva spazi di azione e di rappresentanza, seppure ancora limitati, per quelle categorie finora escluse dai benefici del «miracolo economico». Gli attori delle proteste del 2010 hanno trovato, infatti, sia nella dimensione locale della politica sia in quella centrale, degli interlocutori disposti quantomeno a riconoscere le loro esigenze e a riadattare, anche attraverso gli strumenti legislativi, i loro indirizzi. Oltre a ciò, un’apertura della politica alle questioni del lavoro era visibile anche nella diffusa solidarietà rappresentata in modo particolare in ambito universitario, dall’organizzazione di gruppi di studio e di inchiesta sulle condizioni di lavoro delle fabbriche delle zone industriali del Sud-est [SACOM 2010].
Nell’ambito della politica internazionale, quello stesso processo di modernizzazione che pareva avesse restituito all’«impero di mezzo» la sua centralità, perduta a vantaggio dell’impero britannico inizialmente e di quello statunitense poi, subiva una battuta d’arresto. Ed è in quest’ottica che il 2010 pareva rappresentare sia la conclusione di una fase ascendente, coronata dalla grande vetrina internazionale dell’Expo di Shanghai, sia l’inizio di una fase conflittuale di cui la regione dell’Asia Orientale costituiva il terreno principale di scontro.
Al di là della superficie multipolare formatasi nel corso degli ultimi decenni, che aveva visto la Cina tra i principali promotori di un’attenuazione della tradizionale polarizzazione tra Nord e Sud del mondo, gli attori dello scontro erano la Repubblica Popolare e gli Stati Uniti d’America. A poco più di un mese dalla firma del comunicato congiunto (del novembre 2009) che aveva sancito la nascita del G2, iniziava, sin dai primi mesi dell’anno, un processo di screditamento del ruolo internazionale della Cina nei suoi aspetti politico-culturali, economico-finanziari e geopolitici [AM 2009, pp. 226- 235]. Nella pubblicistica occidentale ritornava prepotentemente quell’immagine aggressiva degli anni Novanta che la Repubblica Popolare aveva tentato di cancellare con un atteggiamento che si avvicinasse il più possibile a quello di un potente attore internazionale pacifico e responsabile. Un atteggiamento che si era dispiegato a cominciare dalla crisi asiatica del 1997 sino al plauso della comunità internazionale per il ruolo svolto dalla Cina di locomotiva nell’ambito della recente crisi economica globale [AM 2009, p. 223; W/FP 20 settembre 2010, «China’s maritime aggression should be wake-up call to Japan», passim; W/FT 25 maggio 2010, «US warns over Beijing’s ‘assertiveness’», passim].
In gioco c’erano interessi commerciali, mortificati da una gara di svalutazione delle monete nazionali, e interessi geopolitici legati sostanzialmente al controllo dei traffici e delle risorse del Pacifico, divenuto oramai da tempo il centro nevralgico degli scambi a livello globale. Un controllo che, nel corso degli ultimi decenni, il governo di Pechino aveva costruito intorno non solo alle consuete relazioni bilaterali che la Cina continuava a preferire, ma anche ad una politica multipolare e multilaterale. Questa era rappresentata in particolare dall’ASEAN+3 (ASEAN+Cina, Giappone e Corea del Sud) e dall’EAS (East Asian Summit), che istituzionalizzavano l’interdipendenza economica tra i diversi poli emergenti dell’area [Onnis 2011, p. 75]. Già nel 2009, Barack Obama aveva annunciato l’intenzione di giocare un ruolo più attivo nelle dinamiche regionali, previa contrattazione con la Cina. Nel 2010 quelle intenzioni hanno avuto un séguito concreto, ma, per tutta una serie di circostanze, peraltro già annunciate nell’anno precedente, erano venuti a mancare i presupposti per una cooperazione fattiva e costruttiva fra USA e Cina [AM 2009, p. 224; pp. 229-231].
A partire da queste considerazioni introduttive, il saggio si svilupperà lungo quelli che si ritiene siano stati gli assi caratterizzanti la fase di modernizzazione in atto nella Cina popolare nel 2010: il conflitto sociale nel mondo dell’industria e i conflitti geopolitici in Asia Orientale.
2. Stato, lavoro e capitale. Il diritto di sciopero e il ruolo del sindacato: forme di rappresentanza in transizione
L’ondata di scioperi che, nella primavera-estate del 2010, aveva interessato il settore dell’industria automobilistica straniera, come pure l’infausto fenomeno dei suicidi a catena nella fabbrica di Shenzhen della Foxconn (di proprietà taiwanese), rientravano in un lungo solco di disagi e di proteste di cui si è dato conto nei precedenti volumi di Asia Maior [AM 2007, pp. 323-27; AM 2008, pp. 358-61; AM 2009, pp. 235-37]. Queste ultime erano ormai divenute più intense e più organizzate in seguito alla promulgazione della legge sul contratto di lavoro del 2008 che, non trovando una applicazione diffusa a livello locale, suscitava reazioni di protesta e determinava una maggior consapevolezza dei propri diritti [AM 2007, pp. 332-34; CLB 2009; Chan 2009]. Il punto di svolta nell’anno in questione era rappresentato dall’inedita ampiezza della mobilitazione, dall’accrescersi delle istanze di carattere politico, assenti quasi del tutto sin dai tempi del movimento di piazza Tian’anmen del 1989, e, infine, dall’entità delle richieste accolte sia in ambito salariale sia in ambito politico.
Al fine di leggere analiticamente il significato delle contestazioni operaie del 2010, è opportuno riflettere brevemente sul rapporto esistente tra le riforme economiche liberiste degli ultimi trent’anni e le forme di rappresentanza della classe operaia cinese.
Nelle democrazie occidentali capitalistiche, il conferimento della legittimità legale alla libertà di sciopero, in particolare a livello costituzionale è una delle conquiste principali del movimento operaio. Esso rappresenta una delle forme più significative di presa d’atto ufficiale, da parte delle istituzioni statali, dell’asimmetria della relazione capitale-lavoro e della necessità di tutelare gli interessi dei lavoratori, in quanto parte più vulnerabile di tale relazione. Il diritto di sciopero si è sviluppato, infatti, insieme alle organizzazioni sindacali, quale strumento dei lavoratori dipendenti. Esso è finalizzato a dimostrare un dissenso o a presentare delle richieste al datore di lavoro pubblico o privato nell’interesse collettivo, in un contesto di economia di mercato capitalista.
È interessante notare che, nel caso cinese, la libertà di sciopero è assurta a diritto fondamentale del cittadino, costituzionalmente garantito, negli anni del maoismo più radicale, per poi scomparire del tutto dall’attività legislativa dei governi riformisti di Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao. A partire dai primi anni Novanta, lo stato cinese ha dato avvio ad un’abbondante produzione legislativa in materia di lavoro, ma nessuna disposizione ha mai introdotto la legittimazione dello sciopero, senza tuttavia vietarlo esplicitamente. Assente nella prima costituzione del 1954, il diritto di sciopero si ritrova nell’art. 28 della costituzione del 1975 – emanata al termine della rivoluzione culturale, un anno prima della morte di Mao – e permane nella costituzione successiva del 1978, all’art. 45. Solo quattro anni dopo, invece, nella nuova costituzione del 1982 (tutt’ora in vigore), la libertà di sciopero cessava di essere un diritto costituzionalmente garantito. Si tenga poi conto del fatto che, sebbene nessuna legge vietasse esplicitamente lo sciopero, erano in vigore sanzioni penali molto severe (tra le quali l’art. 290 del codice penale cinese) – applicabili ai danni di eventuali scioperanti – per chi violasse l’ordine pubblico [ZRGX Zhonghua renmin gongheguo xingfa (codice penale), art. 290, p. 247].
Benché inserita tardivamente nella costituzione del 1975, la questione del diritto di sciopero nella Cina socialista – caratterizzata da una classe operaia numericamente esigua, impiegata nelle aziende di stato – era stata affrontata da Mao Zedong e dalla dirigenza politica sin dalla seconda metà degli anni Cinquanta. In un famoso discorso del 1956, Mao aveva affermato: «Bisogna permettere che gli operai facciano scioperi e che le masse facciano dimostrazioni. […] In seguito, quando si modificherà la Costituzione, propongo che venga aggiunta la libertà di sciopero. Bisogna permettere agli operai di scioperare. Ciò favorirà la soluzione delle contraddizioni tra stato e direttori di fabbrica da un lato, masse operaie dall’altro» [Mao Zedong 1956, p. 459].
Un anno dopo, il comitato centrale del partito comunista cinese promulgava un documento dal titolo «Istruzioni per disciplinare lo sciopero dei lavoratori e degli studenti», che esplicitava le problematiche connesse all’esercizio dello sciopero e l’atteggiamento che il PCC avrebbe dovuto tenere sulla questione. Nel documento, il comitato scriveva: «[…] bisogna permettere alla popolazione di scioperare in quanto ciò non vìola la costituzione e in quanto i conflitti e le dispute non si possono risolvere proibendo l’esercizio degli scioperi» [Chang Kai 2005, p. 230].
Sembrerebbe, dunque, che anche nella Cina maoista – in cui il rapporto esclusivo tra classe operaia, unità di fabbrica (danwei), partito e stato avrebbe dovuto garantire una piena rappresentanza degli operai, senza che questi cercassero vie alternative per manifestare il proprio malcontento (quantunque ce ne fosse il motivo) – si registrassero delle insofferenze tra gli operai e i direttori delle aziende statali, con particolare riferimento ai sistemi di potere burocratici interni alle fabbriche [Russo 2009]. Queste insofferenze o contraddizioni avrebbero dovuto essere riconosciute dal partito/stato e affrontate anche con la legittimazione degli scioperi.
Tali posizioni sono da contestualizzare in una realtà urbana (dalla fine degli anni Cinquanta sino alla rivoluzione culturale) estremamente conflittuale all’interno e al di fuori del controllo delle stesse istituzioni sindacali [Tomba 2001, p. 62, 215; Walder 1991, pp. 468- 69]. È difficile stabilire quanto gli scioperi e le manifestazioni di protesta di quegli anni fossero state la causa di quelle prese di posizione di Mao e del partito o quanto, invece, fossero la conseguenza di meri giochi di potere interni. La politica maoista si era tenuta, in realtà, sempre in bilico tra i reali tentativi di rinnovamento dello stile politico del partito, attraverso un confronto con le masse, e le mere competizioni burocratiche tra fazioni [Pozzana, Russo 2007].
In epoca maoista, la funzione del sindacato era simile a quella tradizionalmente svolta dalle associazioni professionali o dalle comunità di villaggio della Cina imperiale: dispensatore di servizi in nome e per conto dello stato centrale. Per svolgere questa funzione non era necessaria un’organizzazione autonoma dallo stato né tantomeno la libertà di fondare associazioni differenti. Esisteva un solo sindacato ufficiale, la federazione nazionale dei sindacati cinesi (zhonghua quanguo zonggonghui), organizzata sulla base del centralismo democratico e divisa dal punto di vista amministrativo in maniera speculare rispetto all’organizzazione del governo e del partito. Alla base di questa struttura vi erano le unità di lavoro (danwei) a cui corrispondeva un sindacato di base, una cellula di partito e un governo locale. Gli organi locali di governo e di partito avevano il compito di approvare la nomina dei leader sindacali, che spesso coincidevano con i dirigenti dell’azienda e costituivano dal punto di vista economico le principali fonti finanziarie del sindacato.
Dopo l’esperienza maoista – caratterizzata da una convivenza burrascosa di azioni di controllo serrato e da altissimi livelli di conflittualità – il principale obiettivo della direzione denghista è stato proprio il costante perseguimento dell’ordine, dell’unità e della stabilità politica. A tal fine occorreva ridurre al minimo il rischio delle competizioni di potere interne al partito ma, soprattutto, bisognava evitare che il suo operato politico fosse oggetto di critica da parte dei soggetti esterni al sistema statale nel suo complesso, facendo in modo che gli affari di partito fossero monitorati e gestiti unicamente dal partito stesso [Blecher 1997, p. 126]. In uno dei suoi discorsi, Deng Xiaoping aveva affermato: «Il lavoro dei comitati rivoluzionari, dei sindacati, delle leghe giovanili, e dell’esercito deve essere portato avanti sotto la direzione centrale del partito. A nessuno e a nes- suna organizzazione è permesso di porsi al di sopra del partito» [Deng Xiaoping 1983, pp. 233].
L’interpretazione critica che Alain Badiou e Alessandro Russo [Badiou 2005; Russo 2006] hanno dato della rivoluzione culturale fornisce un quadro più completo della fine del maoismo che va oltre i mali delle lotte intestine tra fazioni e che, soprattutto, consente di contestualizzare criticamente la svolta liberista di Deng Xiaoping. Per i due studiosi, la rivoluzione culturale è stata una violenta crisi di rappresentanza in cui si è consumato il fallimento della missione dello stato, del partito, come pure del sindacato ufficiale cinese, quali organizzazioni rappresentative della classe operaia. Piuttosto che assecondare nuove forme di rappresentanza politica, i nuovi governi hanno scelto di smantellare il vecchio rapporto privilegiato con la classe operaia e di forgiare nuovi soggetti da rappresentare, trasformando la missione del partito e modificando la natura del rapporto tra il partito-stato e la società.
Le riforme economiche liberiste degli ultimi trent’anni, caratterizzate da una diffusa de-responsabilizzazione e decentralizzazione del potere statale, hanno tracciato le tappe di questo nuovo percorso del partito. Si è trattato di un percorso segnato, innanzitutto, da politiche economiche di apertura ai capitali stranieri e, conseguentemente, da un graduale inserimento del sistema economico e di lavoro cinese all’interno dei meccanismi della concorrenza internazionale. Contestualmente si è assistito ad un progressivo ritiro dello stato centrale che ha prodotto nuove forme di proletarizzazione in vari modi. Vale la pena precisare, infatti, che, nelle aziende statali, il ritiro dello stato ha preso le forme di una ristrutturazione e/o privatizzazione, mentre nelle imprese miste (pubblico-privato) e, in particolare, in quelle private del settore dell’industria leggera, ha preso le forme di una de-regolamentazione del mercato del lavoro, strutturale e funzionale agli investimenti diretti esteri. I vecchi dipen- denti del settore statale, in questo modo, erano stati colpiti da forme di precariato e erano stati spogliati dei meccanismi di sicurezza dell’impiego a vita e dell’assistenza sociale. Mentre la permanenza del sistema dell’hukou – che subordinava il godimento dell’assistenza sociale al mantenimento della residenza permanente – diveniva funzionale a quella politica di de-responsabilizzazione dello stato centrale. Infatti, è accaduto che i contadini, nella loro migrazione dalle campagne verso i distretti industriali delle coste meridionali, abbiano iniziato a costituire l’enorme «esercito di riserva» di manodopera non specializzato e, nel contempo abbiano perduto il diritto all’assistenza e ai servizi statali [Ngai, Chan, Chan 2009, pp. 136-37]. Tutto ciò ha prodotto una ristrutturazione delle relazioni sociali sotto un profilo capitalistico in cui i governi locali e, dunque, il PCC stesso divenivano i principali detentori del potere capitalista, in collusione con gli interessi del capitale transnazionale [Gabusi 2009, pp. 88-100]. In ultima istanza, la legittimità politica e costituzionale conferita tra il 2002 e il 2004 all’ingresso della classe imprenditoriale e affarista tra le fila del PCC ufficializzava da una parte la riuscita formazione di nuovi soggetti da rappresentare e dall’altra ne consacrava la rappresentanza politica.
In un contesto in cui gli operai cinesi da classe privilegiata divenivano, invece, quella più vulnerabile ed in cui, dunque, si rendevano vieppiù necessari nuovi spazi di rappresentanza e di protesta, la struttura e l’organizzazione sindacale ufficiale rimanevano pressoché immutate. È evidente che nella «Cina delle riforme» erano venuti a mancare i presupposti della funzione sindacale tipica dell’era maoista e si rendeva necessario un rinnovamento del ruolo del sindacato e delle sue forme di rappresentanza. Tale processo era reso ancora più complesso dalla permanente dipendenza politica ed economica del sindacato dal partito e dai governi locali che determinava, allo stesso tempo, una subordinazione agli interessi d’impresa [Franceschini 2007, §§8-10]. È proprio su tale scia di rinnovamento che si sono collocate le istanze politiche degli scioperi del 2010.
2.1 Attori e luoghi della mobilitazione: i lavoratori migranti nel Guangdong
Sia la fabbrica di Shenzhen della Foxconn – in cui tra gennaio e maggio si sono suicidati dieci operai – sia quelle della Honda, protagoniste degli scioperi della primavera-estate, sono stabilimenti dislocati nella provincia del Guangdong, nel delta del Fiume delle Perle, e sono caratterizzati da un’alta concentrazione di giovani lavoratori migranti. Il governo, già da diversi anni, era consapevole della situazione di instabilità sociale di tali regioni, determinata dagli squilibri socio-economici del sistema dell’hukou e dalla grave crisi occupazionale seguita alla recessione economica mondiale. Ne è prova il fatto che, già nel 2009 e, successivamente, durante l’estate del 2010 erano circolati diversi documenti e ricerche sulle dimensioni e sulle condizioni di lavoro della liudong renkou (popolazione fluttuante).
Il 2009 si era, infatti, concluso con un documento promulgato dal consiglio di stato e dal comitato centrale del partito in cui si sottolineava la necessità di un coordinamento tra lo sviluppo delle zone urbane e lo sviluppo di quelle rurali. In esso si evidenziava il fatto che i migranti di nuova generazione avessero maggiori aspettative rispetto alla qualità della vita e alle condizioni di lavoro [W/G 31 di- cembre 2009, «Zhonggongzhongyang guowuyuan guanyu jia da tongchou chengxiang fazhan lidu jinyibu hang shi nongcun fazhan jichu de ruogan yijian»]
Nel marzo 2010, l’istituto nazionale di statistica aveva pubblicato un sondaggio basato su un campione nazionale di 7.100 villaggi che, in relazione al 2009, valutava un aumento della popolazione fluttuante pari all’1,9% rispetto al 2008 e un totale di 230 milioni di lavoratori migranti [W/INSG 19 marzo 2010, «2009 nian nongmingong jiance diaochabaogao», passim]. Tra le varie informazioni fornite dal rapporto pubblicato in giugno dalla federazione nazionale dei sindacati cinesi, vi erano invece i dati sulle percentuali di accesso ai servizi assistenziali delle nuove generazioni di lavoratori migranti: solo il 34,8% godeva dell’assistenza sanitaria di base, il 21,3% dell’assicurazione pensionistica e l’8,5% dei sussidi di disoccupazione. Oltre a ciò, il sindacato rilevava una maggior consapevolezza dei diritti sanciti dalle leggi, grazie soprattutto all’incremento dei livelli di istruzione [W/A 21 giugno 2010, «Guanyu xinshengdai nongmingong wenti de yanjiubaogao»]. Un altro sondaggio, effettuato dal sindacato municipale di Shenzhen su 5.000 lavoratori migranti, rilevava che il loro stipendio mensile equivaleva a poco meno della metà rispetto a quello dei residenti urbani di pari livello professionale [W/A 15 luglio 2010, «Shenzhen xinshengdai nongmingong shengcunzhuangkuang diaochabaogao»].
Anche i salari della Foxconn – il più grosso produttore mondiale di beni elettronici per Apple, Dell, IBM, Nokia, Microsoft, Cisco – confermavano questi dati. La multinazionale Foxconn, sussidiaria della Hon Hai di Taiwan, ha stabilimenti produttivi dislocati in tutto il mondo e in diverse regioni della Cina, e, come fanno anche le aziende del settore dell’industria automobilistica, adotta il sistema di produzione just-in-time. Quest’ultimo è un modo di produzione fon- dato sostanzialmente sulla fabbricazione su richiesta e caratterizzato da una riduzione al minimo delle scorte di materie prime o semilavorati necessari per la produzione. Gli stabilimenti produttivi di Shenzhen (Shenzhen Longhua) costituiscono il parco tecnologico più grande di tutta la Cina, in cui lavorano circa 300.000 dipendenti, molti dei quali alloggiano nei quartieri-dormitorio intorno alla fabbrica, organizzati praticamente come una città. Lo stipendio base ammonta a 900 yuan al mese (circa 102 euro) per 40 ore di lavoro alla settimana. Si tratta di una cifra che, sebbene corrisponda al salario minimo consentito, secondo i calcoli del China Labor Bulletin (una ONG con base ad Hong Kong) non è sufficiente per vivere dignitosamente a Shenzhen. Probabilmente è per tale ragione che circa il 72,5% della forza lavoro degli stabilimenti lavora ore di straordinario ben oltre il limite massimo consentito dalla legge [Chan, Ngai 2010, p. 12]
Il settore dell’industria automobilistica aveva ricevuto un impulso importante a metà degli anni zero del Duemila, sulla scia di un piano di ristrutturazione industriale del governo provinciale del Guangdong, mirante ad una modernizzazione tecnologica avanzata, attraverso un aumento degli investimenti esteri. L’obiettivo era quello di dare priorità allo sviluppo di nove «industrie-pilastro», che avrebbero dovuto sostituire quelle storiche dell’elettronica e del tessile a basso valore aggiunto e ad alta intensità di manodopera. Tra le nove industrie era inclusa quella automobilistica, come stabilito dal «piano di sviluppo dell’industria automobilistica della provincia del Guangdong 2005-2010» [W/IHLO, «Appendix II: The Automobile Strategy of the Guangdong Government and the Guangdong Automobile Group», passim]. In particolare, intorno ai colossi giapponesi, Toyota, Honda, Nissan e al gruppo industriale cinese Canton automobili (Guangzhou qiche jituan gufen youxianggongsi), si era sviluppato un complesso circuito di stabilimenti manifatturieri di parti di automobili e di fabbriche di assemblaggio, organizzato tra Guangzhou e i distretti industriali delle prefetture di Foshan e Nansha, situati nel delta del Fiume delle Perle.
È stato possibile ricostruire un quadro piuttosto completo dell’organizzazione della produzione e delle condizioni di lavoro di tale settore grazie a un rapporto sindacale e a un sondaggio di un quotidiano cinese. Il primo è il rapporto sulle condizioni di lavoro negli stabilimenti della Honda, redatto dall’ufficio di rappresentanza della confederazione internazionale dei sindacati (ITUC-CSI) con sede ad Hong Kong (IHLO-ITUC/GUF Hong Kong Liaison Office). Il secondo è il sondaggio condotto dal quotidiano cinese «Meiri jingji xinwen» (Il quotidiano degli affari nazionali) su 15 aziende di assemblaggio e 11 aziende produttrici di parti di auto, dal titolo «Qiche hangye xin chou diaocha» (Sondaggio sul sistema salariale dell’industria automobilistica) [IHLO 2010; W/MJX 7 giugno 2010, «Qiche hangye xin chou diaocha: yixian yuangong xin chou zhangfu jiao di», passim].
Il sondaggio, in particolare, ha rilevato che tra le aziende occidentali, giapponesi e coreane non esistevano grosse differenze nei livelli salariali annui, mentre i salari elargiti dalle aziende cinesi erano decisamente più bassi: circa 60.000 yuan all’anno, contro 30.000 yuan (circa 7.000 euro contro 3.500). Inoltre, si evidenziava che, a fronte di una crescita del 48% nella vendita di auto registrata nel 2009, i salari dei lavoratori della catena di montaggio erano cresciuti solo del 10%. Per di più, alla bassa crescita salariale corrispondeva un peggioramento delle condizioni di lavoro e un aumento dei differenziali salariali tra i dirigenti e gli operai, perfino maggiori nel caso dei dirigenti non cinesi.
L’azienda da cui è partito l’effetto domino degli scioperi del 2010, diffusosi anche al di là dei confini della provincia del Guangdong, è stata la Honda Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. («Ben tian qiche ling bujian youxianggongsi»), situata nel parco industriale del distretto Nanhai della prefettura di Foshan. L’azienda di proprietà giapponese, fondata nel 2005 dalla Honda Motor Co., Ltd., nel 2010 occupava circa 2.000 lavoratori, la maggior parte dei quali migranti provenienti dalle zone rurali circostanti, retribuiti con bassi salari, stagnanti e per nulla corrispondenti agli alti livelli di profitto della compagnia. In una lettera di protesta dei lavoratori si leggeva: «La nostra fabbrica sta generando miliardi di yuan all’anno e questo profitto è creato con il sudore ed il lavoro degli operai» [W/IHLO 3 giugno 2010, «Open Letter from the Delegation of Representatives of the Honda Strike Workers for Negotiation», §4]. Il salario base mensile del livello più basso di specializzazione era pari a circa 675 yuan (circa 77 euro), inferiore rispetto al salario minimo fissato dalla prefettura di Foshan di 920 yuan. Coloro che percepivano il salario base più basso erano gli stagisti delle scuole professionali (500 yuan al mese – circa 57 euro – senza assicurazione sociale), i quali costituivano il 30% dell’intera forza lavoro della fabbrica. Nella fase di assemblaggio, in cui è richiesto un basso livello di specializzazione, gli stagisti arrivavano a costituire l’80% della forza lavoro [IHLO 2010, pp. 7-10].
Secondo il rapporto dell’IHLO, nel Guangdong vi è stata una forte tendenza all’istituzionalizzazione e alla promozione, da parte del governo locale, di forme di occupazione irregolari, in particolare dei giovani stagisti provenienti dalle zone rurali meno sviluppate. La loro assunzione, infatti, rientrava nei programmi ufficiali di alleviamento della povertà del governo, di impiego del surplus di manodopera delle zone rurali e di incremento dell’offerta di lavoro per i nuovi piani industriali del Guangdong. È chiaro che la preponderante presenza di stagisti rivelava due aspetti importanti: il primo era che anche il settore dell’industria automobilistica rimaneva un settore con bassi livelli di specializzazione e ad alta intensità di lavoro; il secondo era che esisteva un accordo specifico tra il governo locale e le aziende in merito alla formazione professionale e al tirocinio dei giovani migranti in funzione dell’abbassamento del costo del lavoro [IHLO 2010, pp. 14-17].
2.2 Il movimento operaio, le aziende e le istituzioni locali
Risulta particolarmente utile ai fini di questa analisi, la chiave di lettura elaborata dalla studiosa Beverly Silver [Silver 2003; Silver e Zhang 2010]. In relazione al dibattito sulla fuga del capitale industriale verso le zone con manodopera a basso costo quale causa principale dell’indebolimento della classe operaia nei paesi capitalisti avanzati, Silver ha riflettuto sul fatto che questo processo di espansione del capitalismo contemporaneo ha favorito la nascita di nuove forme di proletariato con inedite capacità di rafforzamento e resistenza proprio nei nuovi luoghi di destinazione del capitale in fuga. Da queste nuove forme sono nati, infatti, i movimenti operai degli anni Settanta e Ottanta, che hanno fornito un contributo significativo ai processi di democratizzazione di quei paesi, come è accaduto nella Corea del sud e a Taiwan. Scrive Silver: «Mentre il lavoro è stato indebolito nei luoghi da cui il capitale produttivo è emigrato, nuove classi operaie sono state create e rafforzate nei nuovi siti di investimento. Quindi ognuno dei «miracoli» economici del lavoro a basso costo […] ha creato nuove classi operaie collocate strategicamente, che a loro volta hanno prodotto nuovi movimenti operai radicati nelle industrie in espansione della produzione di massa. Questi movimenti operai hanno avuto successo non solo nell’ottenimenmento di aumenti salariali e nel miglioramento delle condizioni di lavoro; sono stati anche i soggetti «chiave» dietro la diffusione della democrazia nel tardo ventesimo secolo» [Silver 2003, p. 6]. Uno degli elementi di forza delle nuove classi operaie potrebbe essere stato, secondo l’autrice, il sistema produttivo del just-in-time: «[…] in alcune circostanze il sistema produttivo del just-in-time (JIT) in realtà aumenta la vulnerabilità del capitale derivante dalle interruzioni del flusso della produzione, e dunque può incrementare un potere contrattuale dei lavoratori fondato su di una loro azione diretta in un punto specifico del processo produttivo» [Silver 2003, p. 7].
Gli scioperi del 2010 – scaturiti dallo stabilimento della Honda e diffusisi a macchia d’olio in tutto il settore dell’industria automobilistica – sono stati scioperi auto-organizzati al di fuori del perimetro legale come pure del perimetro istituzionale del sindacato ufficiale. L’organizzazione degli scioperi, in quanto azioni di protesta non contemplate dalla legge, non è stato un elemento di novità. La storia recente della Cina contemporanea, infatti, è costellata da scioperi.
La prima novità fondamentale è stata la presa di coscienza di sé e del proprio ruolo critico nella catena produttiva e nella consegna just-in-time da parte delle nuove generazioni di lavoratori migranti, che possono effettivamente rientrare in quelle forme nuove di proletariato di cui discuteva Beverly Silver. La loro azione ha bloccato effettivamente il processo produttivo in quattro fabbriche di assemblaggio, consentendo agli scioperanti di contrattare aumenti salariali pari a circa 800 yuan in più al mese in circa 100 compagnie in tutta la regione. Inoltre, tali azioni hanno provocato proseliti anche in altre fabbriche ed in altre provincie della Cina, determinando una trasformazione delle usuali modalità di sciopero, solitamente localizzato e arginato all’interno dei confini di ogni singola fabbrica e, dunque, più facilmente controllabile. [IHLO 2010, p. 12; W/CSG 9 giugno 2010, «Some Thoughts on Foxconn and the Honda Strike» passim; W/CSG 30 ottobre 2010 «Auto Industry Strikes in China», passim].
Un’altra importante novità risiede nel fatto che le proteste del 2010 non sono state dirette soltanto a difendere diritti contemplati da disposizioni legislative, che sono scarsamente applicate. Esse miravano, infatti, a conquistare diritti non ancora riconosciuti, tanto che, in un’intervista effettuata dal «China Labor Bullettin», i lavoratori scioperanti affermavano: «Nessuno di noi comprende la legge molto bene. Ci dicono che il nostro sciopero è contro la legge, ma non ci preoccupiamo. Se è illegale, allora è illegale. Potete licenziarci tutti e allora l’intera vostra produzione sarà bloccata» [W/CLB 15 settembre 2010, «The Strike that Ignited China’s Summer of Worker Protests», §19]. I lavoratori scioperanti si mostravano determinati a proseguire la lotta al di fuori del perimetro istituzionale e mettevano in rilievo l’importante dilemma della rappresentatività sindacale, spostando il baricentro del conflitto dal sociale al politico.
Nel bel mezzo dello sciopero della Honda – che ha coinvolto quasi 2.000 lavoratori migranti regolari e irregolari e che si è protratto per due settimane – i lavoratori hanno eletto direttamente, in presenza del sindacato ufficiale in qualità di osservatore, una delegazione di 16 rappresentati, avente l’onere di contrattare con la direzione aziendale. Nella lettera aperta scritta dalla delegazione si leggeva: «Noi chiediamo una ristrutturazione della filiale sindacale aziendale […]. Noi insistiamo affinché i rappresentanti sindacali locali siano eletti dai lavoratori della catena di montaggio. […] Il sindacato non ci ha rappresentato. Ha solo rappresentato l’azienda. […] Adesso chiediamo le dimissioni del presidente, una riorganizzazione del sindacato e nuove elezioni» [W/IHLO 3 giugno 2010, «Open Letter from the Delegation of Representatives of the Honda Strike Workers for Negotiation», §§ 2,5,16]. Secondo Anita Chan, nota studiosa del sistema sindacale cinese, con tale mobilitazione i lavoratori non miravano a costituire dei sindacati alternativi alla federazione nazionale dei sindacati cinesi, quanto a riformare democraticamente i suoi comitati locali – reclamando il sistema di elezione democratica dei comitati di base, già in uso in alcune aziende – e a renderli indipendenti dalle aziende e dai governi locali [Chan A. 2010].
Benché avessero organizzato un’azione di resistenza non contemplata da alcuna legge e al di fuori del sindacato ufficiale, gli attivisti hanno ottenuto un interlocutore locale istituzionale anche in relazione alle istanze politiche. La federazione sindacale della provincia del Guangdong, infatti, ha annunciato che il sindacato aziendale sarebbe stato sottoposto ad una riforma democratica e che, in futuro, i suoi leader sarebbero stati eletti dagli operai. Inoltre, Kong Xianghong, il vice presidente della federazione provinciale, ha dichiarato che la presidenza, da quel momento in poi, sarebbe stata sottoposta ad una valutazione del proprio operato annuale, con il rischio di essere esautorata qualora non fosse stata in grado di ottenere il 50% dei voti [W/CLB 15 settembre 2010, «The Strike that Ignited China’s Summer of Worker Protests», §§ 4-5].
La questione sindacale, scaturita nell’anno in questione, non era una novità. I governanti di Pechino, già da tempo, avevano messo in pratica tentativi di rinnovamento delle funzioni del sindacato ufficiale. Nel 2001, infatti, durante la leadership di Jiang Zemin, era stata emendata la legge sindacale del 1992. Gli emendamenti agli articoli 2 e 6, in particolare, parevano disciplinare in maniera più rigorosa il dovere di rappresentanza degli interessi dei lavoratori [Franceschini 2007, §8]. L’articolo 27, inoltre, pur non menzionando la parola «sciopero» (bagong) ma prevedendo episodi di «blocco o rallentamento del lavoro» (tinggong o daigong), rappresentava, secondo Chang Kai, supervisore dell’istituto di relazioni industriali dell’Università Renmin, un primo passo verso il riconoscimento del diritto di sciopero [Chang 2005, p. 248]. Questo passo in avanti avrebbe potuto abilitare ufficialmente la federazione nazionale dei sindacati cinesi (FNSC) ad azioni di protesta di tal tipo.
In realtà, esisteva una complessa rete di interdipendenze tra le autorità politiche, le aziende e i sindacati locali che limitava fortemente il cammino del sindacato ufficiale cinese verso spazi di autonomia e di rappresentanza effettivi. Essa, sancita a livello legislativo, affondava le sue radici sia nelle dinamiche sociali tradizionali sia nel processo di decentramento posto in essere da Deng Xiaoping. La legge sindacale, infatti, decretava la dipendenza economica del sindacato non solo dall’azienda ma anche dai sussidi del governo locale (artt. 42 e 45), stabiliva che il compito principale del sindacato era lo sviluppo economico (art. 4) e che «contestualmente alla protezione degli interessi di tutto il popolo cinese, i sindacati devono rappresentare e salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori» (art. 6) [LSC 1992]. Ciò condizionava in maniera significativa l’atteggiamento del sindacato nei confronti degli scioperi auto-organizzati del 2010. Si era verificata, infatti, la stessa situazione che il politologo Chen Feng descriveva con riferimento alla Cina di dieci anni prima, caratterizzata dai tentativi di persuasione da parte dei dirigenti sindacali ad abbandonare la protesta; tentativi che, nel caso in questione, si erano trasformati in scontri violenti tra lavoratori scioperanti e sindacalisti [Chen 2003, p. 1019; W/REU 1° giugno 2010, «Honda China Production still out after Strike and Clashes», passim]. La novità è stata che la delegazione dei lavoratori scioperanti della Honda ha condannato il comportamento del sindacato ufficiale per aver tentato di bloccare lo sciopero, per aver recapitato all’azienda una «lettera di scuse» in relazione all’azione intrapresa dagli operai e per aver indotto i tirocinanti a firmare un «impegno a non scioperare» [W/IHLO 3 giugno 2010, «Open Letter from the Delegation of Representatives of the Honda Strike Workers for Negotiation», §5].
L’apertura al mercato globale e la politica di decentralizzazione costituivano un’altra ragione alla base dell’interdipendenza tra governi locali, aziende e sindacati. L’autonomia amministrativa e fiscale dei governi locali rientrava del resto nell’ottica globale di frammentazione dell’autorità centrale e di inasprimento della competizione intergovernativa, con la finalità di rendere più efficiente la gestione economica statale [Bardhan Pranab 2002, pp. 185-86]. Secondo Pun Ngai e Jenny Chan, esperte di studi sul mondo del lavoro cinese ed in particolare sul lavoro informale, sin dai primi anni Ottanta esisteva fra i governi locali una forte competizione allo scopo di attirare investimenti stranieri nel proprio territorio, con una corsa al ribasso del costo del lavoro. Il caso Foxconn del 2010 ne costituiva un esempio. Sebbene, infatti, l’azienda avesse deciso di incrementare del 122,2% i salari nelle fabbriche di Shenzhen (da 900 yuan a 2.000 yuan al mese), dopo lo scandalo dei suicidi aveva anche pianificato di dislocare parte della sua attività produttiva in particolare tra Chongqing e Chengdu. Si tratta di due municipalità della Cina interna interessate a crescere economicamente, attirando i capitali della Foxconn con sgravi fiscali, con un salario minimo molto più basso rispetto a quello di Shenzhen e con accordi siglati dall’azienda con centinaia di scuole professionali, impegnate a sfornare manodopera a basso costo [Chan, Ngai 2010, p.12].
Gli stessi sindacati, rifletteva Jenny Chan, riportando la dichiarazione di un funzionario sindacale, operavano seguendo le stesse logiche: «Agli investitori stranieri io dico che il nostro sindacato è, dopo tutto, sotto la dirigenza del partito comunista cinese […]. Il partito vi invita ad investire nel nostro paese, voi cercate profitti e il compito del nostro sindacato sarà quello di proteggere la vostra stabilità e di aiutarvi ad accumulare profitti, facendo in modo che i lavoratori non costituiscano un problema. Se non acconsentite alla fondazione di un sindacato al vostro interno, quando i lavoratori protesteranno non ci sarà nessuno a cui rivolgervi per risolvere i vostri problemi» [Chan 2009, p. 45]. Tale dichiarazione è da contestualizzare nell’ambito della campagna di sindacalizzazione e di regolarizzazione dei lavoratori migranti occupati nelle multinazionali straniere, lanciata da Hu Jintao e Wen Jiabao all’inizio del loro mandato. A partire dal caso della catena di supermercati statunitensi Wal-Mart, infatti, la gran parte dei colossi del mercato globale operanti in Cina era stata obbligata ad accogliere un sindacato ufficiale al proprio interno, ma non senza soluzioni di compromesso [W/E 31 luglio 2008, «Membership Required», passim; Blecher 2009, p. 106].
3. Crescita stabile e «inclusiva»: verso il 12° piano quinquennale (2011-2015)
Gli aumenti salariali seguiti al caso Foxconn e agli scioperi nell’industria automobilistica rientravano in una politica economica già in atto da diverso tempo, tesa a ridurre il crescente divario socio-economico e a costruire un solido mercato di consumi interni [AM 2007, pp. 327-30; AM 2009, p. 243].
Da un lato, la Cina si riconfermava un’economia stabile, in tempo di recessione economica, grazie ad una crescita molto sostenuta che, proprio nel 2010, sorpassava il Giappone e diventava la seconda potenza economica mondiale. Nei primi quattro mesi dell’anno, per effetto del pacchetto di stimoli fiscali del 2008-2009, il tasso di crescita del PIL aveva raggiunto l’11,9%, per poi calare e assestarsi nel terzo quadrimestre dell’anno al 9,6% [AM 2009, pp. 242-44; ADB 2010, p. 132; W/WB 2010, p. 1].
Da un altro lato, la dirigenza di Pechino era dichiaratamente consapevole dei gravi squilibri nello sviluppo economico del paese e del fatto che fosse necessario ridimensionarli sia per evitare l’intensificazione del conflitto sociale sia per liberarsi dalla dipendenza dalle esportazioni [W/NYT 15 agosto 2010, «China Passes Japan as second-largest Economy», passim; W/CD 11 giugno 2010, «Addressing Social Conflicts», passim; Hu Jintao 2010, §9].
Questa volontà politica, che rappresentava una soluzione di continuità con gli anni precedenti, veniva rafforzata e resa più esplicita nella seconda metà dell’anno con l’adozione, da parte del 5° plenum del XVII congresso del PCC (15-18 ottobre), della «proposta del comitato centrale del PCC di formulazione del XII piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Cina (2011-2015)». La proposta sarebbe stata sottoposta all’approvazione dell’assemblea nazionale del popolo nel marzo del 2011 [W/XNHA 18 ottobre 2010, «Full Text of the Communique of the 5th Plenum of the 17th CPC Central Committee», §4].
Il punto nodale della proposta era costituito dall’obiettivo di trasformare il modello di sviluppo attraverso un’attenzione particolare all’estensione della domanda interna e all’espansione del settore terziario, proseguendo nel solco della politica di riforme e di apertura al mercato internazionale del modello denghista.
Alla base di questo disegno vi era una serie di misure che avrebbero dovuto contribuire a creare le condizioni necessarie per lo sviluppo dei consumi interni. Rientrava, fra queste, la politica degli aumenti salariali, con particolare riguardo ai livelli professionali più bassi, in proporzione agli aumenti della produttività e nell’ottica di una più equa distribuzione dei redditi. Da gennaio a giugno, la politica di aumenti salariali aveva determinato una crescita dei redditi reali urbani del 7,5% e di quelli rurali del 9,5% [WB 2010, pp. 3-6]. L’accelerazione del processo di urbanizzazione e la riforma del sistema dell’hukou erano altri due strumenti che il governo centrale considerava fondamentali per lo sviluppo del mercato interno. Il rapporto dell’Asia Development Bank riferiva, infatti, che i governi proseguivano con la politica di elargizione di permessi di residenza permanenti, tesa ad estendere i benefici dell’assistenza sociale ai lavoratori migranti [AM 2007, p. 328; ADB 2010, pp. 134-35; W/XNHA 18 ottobre 2010, «Full Text of the Communique of the 5th Plenum of the 17th CPC Central Committee», §10].
Un altro tassello facente parte delle misure volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e a ridurre il divario tra le zone urbane e quelle rurali era senz’altro la riforma del sistema sanitario, inaugurata a metà del 2009 e affidata al vice presidente Li Keqian. Al principio del 2010, il ministro delle Finanze annunciava che la somma stanziata per tale riforma sarebbe stata pari a circa 37,2 miliardi di yuan (4,24 milioni di euro) per l’anno in corso [W/XHNA 12 febbraio 2010, «La Cina alloca 32.7 bln di yuan per la riforma sanitaria nel 2010», §1]. In un anno, dalla fine del 2009 alla fine del 2010, il governo registrava un aumento degli investimenti dello stato centrale pari al 40% e sosteneva che, nel mese di settembre del 2010, circa il 95,9% della popolazione rurale risultava coperto dal nuovo sistema sanitario cooperativo per le zone rurali [W/C 1° dicembre 2010, «Chine: couverture de 70 % des frais médicaux en 2015», §2].
Infine, in relazione alle questioni specifiche del mondo del lavoro, il discorso pronunciato da Hu Jintao in occasione del 4° incontro ministeriale dell’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) sullo sviluppo delle risorse umane (Pechino, 16 settembre) conteneva quattro proposte che esplicitavano la direzione che Pechino intendeva seguire a tal proposito. Il presidente dell’RPC, ribadendo il significato del concetto di «crescita inclusiva» (pronunciato per la prima volta nel 17° incontro dei leader dell’economia dell’APEC del 2009) in quanto profondamente vicino alla retorica della «società armoniosa», proponeva una cooperazione in quattro ambiti d’azione: priorità allo sviluppo delle risorse umane; strategia di piena occupazione; miglioramento delle qualità e competenze dei lavoratori; costruzione di sistemi di sicurezza sociale nazionali. In particolare, Hu poneva l’accento su altri punti ritenuti fondamentali, come la necessità di un’attiva politica di promozione dell’impiego attraverso misure industriali, fiscali e finanziarie mirate; la promozione di relazioni industriali armoniche; la realizzazione di una «società orientata all’istruzione, in cui l’istruzione giochi un ruolo fondamentale nel processo di miglioramento delle qualità e capacità dei lavoratori» [Hu Jintao 2010, §4].
A rendere più complesso questo processo di rafforzamento del mercato interno e di riappacificazione del conflitto sociale non contribuiva solo la già discussa difficoltà di applicare localmente le direttive centrali. Anche la perdurante inflazione, infatti, giocava un ruolo negativo fondamentale nel mantenimento della stabilità economica, sociale e politica.
Nel mese di novembre il tasso di inflazione era aumentato del 5,1% rispetto all’anno precedente. A crescere erano soprattutto i prezzi dei beni alimentari, che, rispetto al 2009, erano aumentati dell’11,7% [W/E 1° gennaio 2011, «Inflation Reaches a 28-month high in November», §1]. Tuttavia, era soprattutto la spirale inflazionistica legata al boom immobiliare a suscitare la preoccupazione del governo. A metà dell’anno, il prezzo medio delle case era cresciuto dell’11,7% rispetto all’anno precedente, mentre i prezzi delle case residenziali a Pechino erano cresciuti del 60% rispetto a cinque anni prima [Gabusi 2010, §2].
L’esplosione dell’industria delle costruzioni e, dunque, del mercato immobiliare, era connessa all’accelerazione dell’urbanizzazione. Questa non aveva il semplice obiettivo di modernizzare e migliorare le condizioni di vita della popolazione, come specificato nei documenti ufficiali, ma serviva anche ai giochi speculativi della rete clientelare costituitasi tra imprenditori privati e amministrazioni locali. Gli introiti derivanti dalla locazione dell’uso della terra costituivano, infatti, un’importante fonte di entrate per i governi locali, divenuti, oramai da tempo, i principali partner delle imprese costruttrici. Un sistema del genere colpiva naturalmente le parti più deboli della società. Costringeva, infatti, gli abitanti di quei villaggi rurali che erano stati demoliti per lasciar spazio ai quartieri residenziali a trasferirsi in zone più economiche e indeboliva fortemente il potere d’acquisto della gran parte dei residenti urbani [W/C 2 dicembre 2010, « L’urbanisation chinoise confrontée à quatre défis, selon un ancien fonctionnaire chinois», passim]. Secondo un sondaggio dell’Accademia cinese di scienze sociali, citato dall’«Economist» ed effettuato su 35 piccole e grandi città, l’85% dei residenti urbani non poteva permettersi l’acquisto di una casa propria [W/E 1° gennaio 2011, «Inflation Reaches a 28-month high in November», §4]. Ed infine colpiva il mondo del lavoro, considerato il fatto che l’industria delle costruzioni – la quarta in ordine di grandezza – impiegava senza contratti regolari il 30% dei lavoratori migranti [Ngai, Lu 2010, pp. 143-46].
4. Hong Kong e Taiwan: nuove politiche laburiste
Le politiche di aumenti salariali contagiavano anche la Repubblica di Cina (Taiwan) e la regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
A Hong Kong, tradizionalmente liberista e avente un mercato del lavoro completamente deregolamentato, costituivano una novità assoluta.
Il disegno di legge relativo all’introduzione del minimo salariale passava, il 15 luglio, con 53 voti a favore e uno contrario; il 10 novembre il capo dell’esecutivo, Donald Tsang, accoglieva la proposta di 28 dollari di Hong Kong (HK$) all’ora, equivalenti a circa 2 euro; e il 7 gennaio il consiglio legislativo approvava il disegno di legge ed il minimo salariale (senza avere la possibilità di emendarlo). I sindacati si dicevano soddisfatti nonostante il livello minimo stabilito fosse inferiore di 5HK$ (0,48 euro) rispetto a quello da loro richiesto; d’altronde era superiore di altri 5HK$ rispetto a quello proposto dalla controparte imprenditoriale. A parte il minimo salariale, la nuova legge introduceva altri obblighi che davano l’avvio ad una trasformazione graduale delle relazioni industriali, tra cui i limiti all’orario di lavoro; il divieto di apprendistato gratuito; l’obbligo all’elargizione delle ferie o della liquidazione alla fine del rapporto di lavoro. La legge, tuttavia, non poteva essere applicata ai collaboratori domestici stranieri [W/E 11 gennaio 2011, «Only the Beginning», passim].
Tale rinnovamento legislativo era frutto di un cambiamento graduale. La legislazione che dava al governatore della colonia il diritto di imporre un salario minimo risaliva al 1932 ma, in realtà, è stata ridiscussa in maniera profonda a partire dal ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Nel 2006 si era proposta, per esempio, una pianificazione volontaria dei minimi salariali. A tale proposta aveva fatto seguito, nel 2010, l’approvazione di una nuova legge che si inseriva all’interno di un processo di rinnovamento più ampio. Tale legge vedeva il ritorno di un intervento embrionale dello stato nell’economia e la formulazione di una politica industriale, per esempio nell’ambito dei trasporti [W/E 15 luglio 2010, «End of an Experiment», passim].
I sindacati taiwanesi erano molto meno entusiasti per gli aumenti salariali ottenuti di quanto lo fossero i loro colleghi di Hong Kong, dove una tale modifica costituiva comunque una novità. Per tal motivo, nel mese di settembre si protestava a Taipei davanti ai cancelli del ministero del Lavoro. L’aumento del salario minimo ottenuto a Taiwan, che riguardava anche il salario dei lavoratori immigrati e che sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, era effettivamente irrisorio: il 3,47% in più al mese. Il salario sarebbe passato da 17.280 nuovi dollari di Taiwan (NT$) (443 euro) a 17.880 NT$ al mese (458 euro). I sindacati speravano in un aumento del 28% al mese, tenuto conto dell’incremento del costo della vita nell’isola e del fatto che gli aumenti salariali erano stati congelati tra il 2008- 2009 al fine di contenere la crescente disoccupazione dovuta alla crisi economica mondiale [W/TT 14 settembre 2010, «CLA recommends lifting minimum wage», passim; W/CP 13 settembre 2010, «Top union official support minimum wage hike», passim; Wang 2010, pp. 76-80].
Dal punto di vista della legislazione sul lavoro, nel corso del 2010 si è raggiunto un risultato significativo anche se non soddisfacente dal punto di vista dei lavoratori. Le cosiddette «tre leggi sul lavoro» (legge sindacale, legge sulla contrattazione collettiva, legge sulla risoluzione delle dispute), al centro delle battaglie degli ultimi dieci anni del movimento dei lavoratori taiwanesi, sono state emendate. Si trattava di leggi promulgate negli anni Trenta, quando ancora il Guomindang governava l’intera Cina, ed emendate intorno agli anni Settanta e Ottanta. Erano, dunque, ancora il riflesso di una politica autoritaria e corporativa.
Tra i vari emendamenti introdotti ve ne erano diversi che riguardavano il diritto alla formazione dei sindacati e il diritto di sciopero. Rispetto al passato, si consentiva di costituire una tipologia più varia di sindacati e, soprattutto, si permettevano alleanze sindacali, un tempo proibite. Il divieto di sciopero per i lavoratori dei settori strategici (banche, trasporti, energia, comunicazioni) e per gli insegnanti veniva eliminato; ma la legge sulla risoluzione delle dispute disponeva che il sindacato e l’azienda avrebbero dovuto accordarsi sui termini e sulle condizioni di elargizione dei servizi indispensabili. Si prevedevano, inoltre, sanzioni gravi nei confronti dei datori di lavoro che abusavano del loro potere nei confronti dei sindacalisti; ma si disponeva anche che il governo fosse autorizzato a rimpiazzare i funzionari sindacali qualora violassero la legge e non si adeguassero ad eventuali avvertimenti da parte delle autorità. Questa era la disposizione maggiormente criticata dalle organizzazioni sindacali, che la definivano «legge sindacale marziale» [W/AMRC 11 gennaio 2011, «Taiwan», passim].
5. Conflitti geopolitici
5.1 Rivalità globali
A differenza degli anni precedenti, in cui pareva che le potenze preferissero cooperare alla transizione sistemica degli equilibri mondiali che si stava delineando oramai da tempo, il 2010 è stato un anno contrassegnato da conflitti e forti tensioni sia nell’ambito economico-finanziario, sia in quello geopolitico. Al 5° forum della London School of Economics LSE-Asia, tenutosi a Pechino il 26 marzo, lo storico Odd Arne Westad affermava che il lento processo di riaffermazione di una centralità asiatica – frutto delle trasformazioni degli ultimi vent’anni – non sarebbe potuto avvenire in maniera completamente pacifica. Non tanto a causa di scontri diretti tra la potenza in declino (Stati Uniti) e la potenza in ascesa (Cina), quanto piuttosto a causa di una più generale instabilità e incertezza determinata da tale transizione e capace di generare conflitti. D’altronde, come faceva notare Wang Jisi (direttore della scuola di studi internazionali dell’Università di Pechino), anch’egli presente al forum, lo stesso rapporto tra Cina e Stati Uniti non poteva semplicemente definirsi bilaterale. Era, in realtà, un rapporto onnicomprensivo che abbracciava la questione coreana, i rapporti con il Giappone, il Sud-est asiatico, l’Asia Centrale, l’Iran e tante altre questioni [W/LSEA 25-6 marzo 2010, «China and the World: The Challenge of Change»]. E, come osservava Yan Xuetong (direttore dell’istituto di studi internazionali dell’Università Qinghua), si trattava tra l’altro di un rapporto di per sé instabile, caratterizzato da politiche altalenanti ed ambigue, in particolare dal crollo dell’URSS in poi [Yan 2010].
Queste interpretazioni costituiscono una linea guida interessan- te nell’analisi del repentino cambio di rotta e di retorica delle rela- zioni Cina-Stati Uniti, nel passaggio dal 2009 al 2010. A pochi mesi di distanza dalla cancellazione dell’incontro, per volontà americana, tra Obama e il Dalai Lama e dal 1° vertice del G2 del novembre 2009, cioè eventi che sembravano puntare ad un’armonizzazione dei rapporti sino-americani, il 2010 si era invece aperto con un serie di tensioni.
Si è partiti dal caso Google, che ha innescato una grave crisi di- plomatica tra i due stati. Dopo aver accusato il governo cinese di spionaggio e di pirateria ai danni dei dissidenti cinesi, la multinazionale ha, infatti, ricevuto manifestazioni di solidarietà da parte dell’amministrazione americana, che ha chiesto chiarimenti alle autorità cinesi [W/S 24 marzo 2010, «Geopolitica di google», §§3-7]. In gennaio i dissapori sono poi proseguiti con la vendita di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti, alla quale Pechino ha reagito con un congelamento dei rapporti militari e il temporaneo rifiuto della visita di Robert Gates, segretario della Difesa statunitense [W/REU 8 gennaio 2010, «China again denounces US arms sale to Taiwan», passim]. In aggiunta a ciò, in febbraio il Dalai Lama si recava alla Casa Bianca in visita ufficiale e, alla fine dell’anno, divampava la polemica sulla politica di boicottaggio lanciata da Pechino nei confronti della cerimonia di consegna del Premio Nobel per la pace 2010 al dissidente cinese Liu Xiaobo, attivista dell’89 e co-autore della cosiddetta Carta ’08. In tale circostanza, l’amministrazione Obama adottava una posizione molto meno pragmatica rispetto alla retorica dell’anno precedente [W/WP 17 febbraio 2010, «As the world watches, Dalai Lama will meet with Obama at the White House», passim; W/AG 9 dicembre 2010. «Nobel Laureate Liu Xiaobo ‘Deserves Our Admiration’, Us says», passim].
All’interno di tale cornice polemica, nella quale la questione dei diritti umani ritornava ad avere un ruolo determinante, si palesavano rivalità geopolitiche ed economiche estremamente significative, che allontanavano la realizzazione del progetto cinese di un «ordine mondiale armonico» [AM 2007, p. 349].
In un tale contesto di crescente ostilità nei confronti della Cina popolare, sarebbe opportuno riflettere sulla complessità della società cinese, del rapporto che essa ha con il governo centrale e, soprattutto, sul ruolo del nazionalismo nell’ambito degli equilibri internazionali. Il politologo Minxin Pei esprimeva chiaramente le contraddizioni esistenti nel 2010 tra la percezione della Cina all’esterno e la percezione che i cinesi stessi hanno della politica estera cinese: «Oggigiorno Cina e ‘autoaffermazione’ sono diventati praticamente sinonimi. Il ritratto dell’impero di mezzo nella stampa occidentale è ovunque poco lusinghiero. La Cina mantiene una svalutazione della moneta per guadagnarsi dei vantaggi commerciali ingiusti; molesta i suoi vicini riaccendendo dispute territoriali; non fa nulla per contenere il pericoloso regime nord-coreano e, nonostante la sua crescente aggressività, continua a sostenerlo economicamente. All’interno della Cina, invece, la percezione dell’atteggiamento internazionale di Pechino è sostanzialmente l’opposto. La gran parte dell’opinione pubblica ritiene che il governo cinese non sia sufficientemente reattivo. Considera i propri governanti privi di spina dorsale e ritiene la critiche occidentali ingiuste e ipocrite» [W/FT 25 novembre 2010, «Why the west should not demonise China», §1].
5.2 Rivalità geopolitiche in Asia Orientale e Sud-orientale
Tra marzo e aprile 2010 la stampa e la pubblicistica occidentale e asiatica denunciavano l’estensione delle ambizioni navali cinesi ben oltre le coste dell’RPC. Secondo tali fonti, le autorità cinesi miravano ad estendere il loro controllo dai porti del Medio Oriente fino allo stretto di Malacca in modo da proteggere i propri traffici commerciali. D’altronde, in marzo, si registrava per la prima volta la presenza di due navi da guerra cinesi nel porto di Abu Dhabi. Inoltre, si riportava che due funzionari cinesi avrebbero riferito a due funzionari dell’amministrazione Obama che la Cina non avrebbe più tollerato alcuna interferenza nel Mar Cinese Meridionale. Questa zona entrava, infatti, ufficialmente a far parte degli interessi fondamentali della Cina, alla stessa stregua di Taiwan e del Tibet. L’ammiraglio americano Robert F. Willard (comandante delle forze statunitensi nel Pacifico) sosteneva che, sebbene ancora incomparabili con il potere militare statunitense, i recenti sviluppi militari cinesi rappresentavano un drammatico balzo in avanti e «la preoccupazione principale era che la modernizzazione militare cinese paresse diretta a sfidare la nostra [degli USA] libertà d’azione nella regione». Infine, il «New York Times» specificava che il Pentagono non classificava la Cina quale nemico degli USA ma, comunque, stesse trasferendo una parte consistente della flotta sottomarina dall’Atlantico al Pacifico [W/NYT 23 aprile, «Chinese Military Seeks to Extend its Naval Power», passim; W/JT 9 maggio 2010, «Beijing projects power in South China Sea», passim; W/AT 20 agosto 2010, «Deep reasons for China and US to bristle», §§1-8].
Il Mar della Cina Meridionale è un’area geopolitica di immenso valore strategico, in cui convergono gli interessi di tutte le potenze della regione, Stati Uniti inclusi. Si tratta di acque ricche di risorse ittiche e naturali (petrolio e gas metano) che sono, oltretutto, attraversate da una parte enorme del flusso di merci mondiale e di petrolio (circa il 60%). Questa regione si contraddistingue, inoltre, per le dispute territoriali in corso da lungo tempo, che le circostanze del 2010 contribuivano ad arroventare: le isole Paracel, contese tra la Cina, Taiwan e il Vietnam; le isole Spratly, contese oltre che tra le prime tre, anche dalle Filippine, dalla Malaysia e dal Brunei.
In occasione del Forum regionale dell’ASEAN (ARF), tenutosi ad Hanoi nel luglio del 2010, l’atteggiamento e le preoccupazioni degli Stati Uniti raccoglievano consensi in seno all’ASEAN. Gli USA, attraverso le parole del segretario di stato Hillary Clinton e in riferimento alla denunciata aggressività della Cina, si impegnavano a difendere la libertà di navigazione nella regione, promuovendo a tal fine una politica di accordi multilaterali [W/NYT 23 luglio 2010, «Offering to Aid Talks, US Challenges China on Disputed Islands»,passim; W/E 2 dicembre 2010, «In the Balance», §§10-14]. Tra i vari paesi dell’ASEAN, l’impegno multilaterale degli USA veniva accolto con favore in particolare dal Vietnam – con il quale in agosto si dava inizio ad una cooperazione militare e nucleare – ma anche da Singapore, dalle Filippine, dalla Malaysia e dall’Indonesia. Con quest’ultima gli Stati Uniti stringevano una collaborazione onnicomprensiva, che prevedeva anche accordi di tipo militare [W/WH 9 novembre 2010, «Fact Sheets: The United States and Indonesia – Building a 21st Century Partnership», passim; Kurlantzick 2010, §4]. Inoltre, in seguito alla decisione dei paesi dell’ASEAN, emessa in occasione del 2° incontro ASEAN-USA (New York, settembre), di ammettere gli USA e la Russia all’interno dell’East Asia Summit, gli Stati Uniti si assicuravano maggiori capacità di manovra, di osservazione e di controllo all’interno del contesto asiatico. L’ASEAN accoglieva, infatti, la richiesta di partecipazione del presidente Obama all’EAS del 2011 e invitava Hillary Clinton in qualità di ospite al summit dell’EAS dell’ottobre 2010 [W/WH 24 settembre 2010, «Joint Statement of the 2nd US-Asean Leaders Meeting», §5].
Questi equilibri già delicati venivano ulteriormente complicati da una nuova esplosione della questione coreana. In marzo la Corea del nord, storico alleato dell’RPC, affondava la nave militare sud-coreana «Cheonan» nel Mar Giallo e in novembre bombardava l’isola sud-coreana di Yeonpyeong. Da un lato, Washington condannava immediatamente gli attacchi e dava inizio ad una serie di esercitazioni militari congiunte tra la marina militare statunitense e quella della Corea del sud, esplicitando palesemente, in accordo con il presidente sud-coreano Lee Myung-bak, l’intenzione di un ridimensionamento della funzione degli «incontri diplomatici a sei» in tali mutate circostanze. Dall’altro lato, l’RPC continuava a sostenere economicamente e diplomaticamente la Corea del nord, esortava alla calma, alla moderazione e al ricorso agli «incontri diplomatici a sei» [W/RMRB 26 novembre 2010, «Beijing rinnova la richiesta di moderazione per le tensioni della penisola coreana», passim]. Le posizioni delle due grandi potenze si scontravano in giugno, in occasione del G20 di Toronto, allorquando il presidente Obama specificava che esisteva una grande differenza tra «moderazione ed ostinata cecità verso problemi gravi». Dal canto suo, la Cina rispondeva che, per il solo fatto di confinare con le due Coree, aveva una percezione più profonda della situazione e proponeva, di conseguenza, soluzioni diverse [W/WH 27 giugno 2010, «Remarks by President Obama at G-20 Press Conference in Toronto, Canada», §§44-45; W/XNHA 29 giugno 2010, «China rebuffs criticism over stance on Korean Peninsular situation», §4].
Infine, in settembre subentrava una contesa nel Mar della Cina Orientale, a causa dello scontro tra un’imbarcazione della guardia costiera nipponica e un peschereccio cinese, il cui capitano veniva trattenuto dalle autorità giapponesi perché accusato di spionaggio. L’incidente andava a turbare il delicato equilibrio a proposito di una questione territoriale ancora irrisolta tra la Cina e il Giappone: quella delle Isole Senkaku, attualmente sotto l’amministrazione giapponese, ma contese, oltre che dalle due grandi potenze, anche da Taiwan [W/EAF 30 settembre 2010, «China-Japan trawler incident: Japan’s unwise-borderline illegal-detention of the Chinese skipper», passim].
Nel corso dell’anno si era, dunque, delineato, in Asia Orientale e Sud-orientale, un quadro strategico militare assai favorevole ad una riaffermazione del potere statunitense in Asia e ad un ridimensionamento dell’egemonia economica e politica cinese. In particolare, la questione coreana e la nuova complicazione diplomatica con il Giappone avevano contribuito a produrre una sorta di accerchiamento della Repubblica Popolare Cinese. Alle esercitazioni tra Stati Uniti e Corea del sud avevano, infatti, fatto seguito le più importanti manovre congiunte mai tenute prima di allora tra Stati Uniti e Giappone, alle quali la Corea del sud aveva preso parte in qualità di osservatore [W/XNHA 7 dicembre 2010, «Japan-US military drill starts major field training», §13; W/NTNN 3 dicembre, «Mar Giallo, esercitazioni USA-Giappone. Seul annuncia l’uso dei bombardamenti aerei in caso di nuovo attacco nordcoreano», §1]. Si trattava di un altissimo coinvolgimento militare degli Stati Uniti, del Giappone (suo alleato storico e nemico acerrimo della Cina) e della Corea del sud, a poca distanza dalle coste cinesi. Nonostante fossero esercitazioni formalmente funzionali ad un contenimento della Corea del nord, esse destavano preoccupazioni nei governanti di Pechino, tanto che il quotidiano on line «China Daily» scriveva: «Nonostante le continue proteste cinesi, il pentagono non mostra segni di moderazione. […] Con la partecipazione della portaerei americana George Washington a propulsione nucleare, le esercitazioni espongono al rischio militare le città di Pechino e Tianjin e tutta la zona costiera cinese» [W/CD 28 giugno 2010, «US military presence in the Yellow sea» §4]. Il generale Luo Yuan, segretario generale dell’esercito popolare di liberazione, nell’esporre una critica dettagliata delle esercitazioni tra USA e Corea del sud, chiedeva agli Stati Uniti di porsi nei panni della Cina e di domandarsi quale sarebbe stata la loro reazione nel caso in cui fosse stata la Cina ad effettuare esercitazioni militari di fronte alle loro coste [W/RMRB 16 luglio 2010, «Perché la Cina si oppone alle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del sud», §1].
Il triangolo di sicurezza Washington-Tokyo-Seul e il conseguente isolamento della Cina venivano sostanzialmente istituzionalizzati nel dicembre 2010, quando i ministri degli affari Esteri delle tre potenze si riunivano a Washington allo scopo di trovare una soluzione condivisa sulla questione coreana, non soltanto escludendo la Cina dal consesso decisionale, ma formalizzando anche una richiesta congiunta nei suoi confronti di un impegno ad una maggior responsabilità internazionale nei riguardi di Pyongyang, venuta a mancare fino a quel momento nel contesto del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [W/AG 6 dicembre 2010, «Statement by Japan, South Korea, United States on North Korea», §§2,7,8; Byun 2010].
Agli occhi della Cina popolare, la politica estera statunitense del 2010 era stata intenzionalmente improntata al rafforzamento della presenza politica, economica e militare in Asia Orientale. La diffusione della notizia circa l’atteggiamento aggressivo e difensivo della Cina nel Mar Cinese Meridionale veniva considerata inattendibile da Pechino, se non addirittura intenzionale e volta a internazionalizzare dispute territoriali che, invece, la Cina avrebbe preferito mantenere su un piano bilaterale con i paesi storicamente coinvolti [W/RMRB 27 agosto 2010, «Unwise to elevate ‘South China Sea’ to be core interest», §§ 1-2].
5.3 Rivalità economico-finanziarie: la guerra delle valute
Nel 2010 la persistente crisi economica globale generava, tra i paesi emergenti e anche tra quelli sviluppati (Stati Uniti inclusi), una vera e propria corsa alla svalutazione delle monete nazionali, al fine di incentivare l’aumento delle esportazioni. Gli Stati Uniti e la comunità internazionale nel suo complesso, in più contesti dal G20 all’ASEM, attribuivano alla Cina le maggiori responsabilità ed affidavano ad essa l’avvio di un processo di cooperazione internazionale per mettere fine alle tensioni, rivalutando la sua moneta [W/FT 21 ottobre 2010, «Global Economy-G20 finance chiefs face currency struggle», passim; W/ASEM 6 ottobre 2010, «Summit leaders look to head off currency war» §§8-12].
Durante l’anno in questione, le riserve cinesi in valuta estera erano cresciute del 18,7% rispetto all’anno precedente ed ammontavano a circa 2.850 miliardi di dollari. Al contrario, il valore dello yuan era cresciuto unicamente del 2% rispetto al dollaro americano [W/Agi 11 gennaio 2011, «Le riserve Forex nei forzieri del Dragone», passim]. Anche in questo caso, l’amministrazione Obama attuava una politica meno pragmatica che nell’anno precedente: il 29 settembre la maggioranza della camera dei rappresentanti approvava una legge, su proposta dal deputato Sander Levin, finalizzata alla possibilità di imporre sanzioni alle esportazioni cinesi, qualora si dimostrasse che esse avessero sfruttato il valore artificialmente basso dello yuan. Allo stesso tempo, a distanza di poco più di un mese, la Federal Reserve annunciava l’emissione di carta moneta per un valore pari a 600 miliardi di dollari al fine di abbassare il valore del dollaro e di sostenere l’economia americana. In tal modo si intendeva ridurre il valore dei crediti degli altri paesi, quello della Cina in primis, in quanto primo detentore dei titoli di stato americani [W/Agi 14 ottobre 2010, «La rimonta del dragone», §§ 19,24].
La questione del valore della moneta nazionale cinese era strettamente collegata alle problematiche interne di sviluppo e di contenimento del conflitto sociale in Cina. In ottobre, nell’ambito del contesto europeo, Wen Jiabao invitava l’Unione Europea a non unirsi al coro delle richieste di rivalutazione: «Una rivalutazione veloce dello yuan provocherebbe la chiusura delle fabbriche, gli operai dovrebbero tornare nei campi e ci sarebbero disordini sociali. Non è un bene per nessuno che la Cina soffra» [W/REU 6 ottobre 2010, «China tells EU to stop pressing on currency», §§6-7].
Nell’ambito economico-finanziario delle rivalità globali, la Cina otteneva anche un successo importante. La quota detenuta dall’RPC all’interno del consesso della Banca Mondiale passava dal 2,78% al 4,42%. La Cina diveniva in tal modo il terzo paese al mondo per potere decisionale all’interno dell’organizzazione internazionale, dietro gli Stati Uniti (15,85%) ed il Giappone (6,84%) [W/Agi 14 ottobre 2010, «Cina nel 2010. La rimonta del dragone», §4].
Riferimenti bibliografici
AM
2007 «Asia Maior». L’Asia nel «grande gioco». Il consolidamento dei protagonisti asiatici nello scacchiere globale, Guerini e Associati, Milano 2008.
2008 «Asia Maior. Crisi globali, crisi locali e nuovi equilibri in Asia», Guerini e Associati, Milano 2009.
2009 «Asia Maior. L’Asia di Obama e della crisi economica globale». Guerini e Associati, Milano 2010.
W/A «All China Federation Of Tradeunions» (http://www.acftu.org).
W/AG «America.gov» (http://www.america.gov).
W/Agi «AGIChina 24» (http://www.agichina24.it).
W/AMRC «Asia Monitor Resource Center» (http://www.amrc.org.tw).
W/ASEM «Asia Europe Meeting» (http://www.aseminfoboard.org).
W/AT «Asia Times» (http://atimes.com).
W/CD «China Daily» (http://www.chinadaily.com.cn).
W/C «China» (http://www.china.org.cn).
W/CLB «China Labour Bulletin» (http://www.clb.org.hk).
W/CP «The China Post» (http://www.chinapost.com.tw).
W/CSG «China Study Group» (http://www.chinastudygroup.net).
W/E «The Economist» (http://www.economist.com).
W/EAF «East Asia Forum» (http://www.eastasiaforum.org).
W/FP «Foreign Policy» (http://www.foreignpolicy.com).
W/FT «Financial Times» (http://www.FT.com).
W/G «Consiglio di stato della RPC» (http://www.gov.cn).
W/IHLO «Hong Kong Liaison Office ITUC» (http://ihlo.org).
W/JT «The Japan Times» (http://www.japantimes.co.jp).
W/LSEA «LSE Asia Forum 2010» (http://www2.lse.ac.uk/LSEAsiaForum2010/Home.aspx).
W/MJX «Meiri Jingji Xinwen» (http://www.nbd.com.cn).
W/NTNN «Not In The News Net» (http://www.ntnn.info).
W/NYT «New York Times» (http://www.nytimes.com).
W/REU «Reuters» (http:// www.reuters.com).
W/RMRB «Renmin Ribao» (http://www.peopledaily.cn).
W/S «Il Sole 24 Ore» (http://www.ilsole24ore.com).
W/INS «Istituto Nazionale di Statistica della RPC» (http://www.stats.gov.cn/index.htm).
W/TT «Taiwan Today» (http://www.taiwantoday.tw).
W/WH «White House» (http://www.whitehouse.gov).
W/WP «Washington Post» (http://washingtonpost.com).
W/XNHA «Xinhua News» (http://www.xinhuanet.com).
ADB «Asia Development Bank»
2010 Asia Development Outlook 2010 Update. People’s Republic of China (http://www.adb.org/documents/books/ado/2010/PRC.pdf).
Badiou, Alain
2005 La rivoluzione culturale: l’ultima rivoluzione?, in Tommaso Di Francesco (a cura di), L’assalto al cielo. La rivoluzione culturale cinese quarant’anni dopo, ManifestoLibri, Roma, pp. 37-72.
Bardhan, Pranab
2002 Decentralization of Governance and Development, «Journal of Economic Perspectives», vol. 16, n° 4, pp. 185-205.
Blecher, Marc
1997 China Against the Tides. Restructuring through Revolution, Radicalism and Reform, Pinter, London and Washington.
2009 Globalization, Structural Reform, and Labour Politics in China, «Global Labour Journal», 1° volume, special issue in Globalization(s) and Labour in China and India, pp. 92-11.
Byun, See-Won
2010 North Korea’s Provocations and their Impact on Northeast Asian Regional Security, «Center for US-Korea Policy, The Asia Foundation», dicembre (http://www.asiafoundation.com/resources/pdfs /ByunNorthKoreasProvocationsDec2010.pdf).
Chan, Anita
2010 Labour Unrest and Role of Unions, «China Daily» (www.chinadaily.com.cn/opinion/2010-06/…/content_9987347.htm).
Chan, Jenny
2009 Meaningful Progress or Illusory Reform? Analyzing China’s Labor Contract Law, «New Labor Forum», vol.18 (2), spring, pp. 43-51.
Chan, Jenny e Pun Ngai
2010 Suicide as Protest for the New Generation of Chinese Migrant Workers: Foxconn, Global Capital, and the State, «The Asia-Pacific Jour- nal» 37, 2, 10, 13 settembre (http://japanfocus.org/-Jenny-Chan /3408).
Chang, Kai
2005 The Legislation of Right to Strike in China, «International Society for Labor and Social Security Law 8th Asia Regional Congress», 31 ottobre-3 novembre, Taipei (www.airroc.org.tw/ISLSSL200 5/program/doc/II-3.doc).
Cheng, Li
2010 China’s Five Year Challenge. China’s market-focused next Leader, intervistato da «Reuters Insider», 22 ottobre, (http://insider.thom sonreuters.com/link).
CLB (China Labour Bulletin, ONG fondata ad Hong Kong nel 1994)
2009 Going it Alone. The Workers’ Movement in China 2007-2008, Research Report, luglio, (http://www.clb.org.hk/en/files/share/File/re search_reports/workers_movement_07-08_print_final.pdf).
Deng, Xiaoping
1983 Selected Works of Deng Xiaoping (1975-1982), Foreign Language Press, Beijing.
Franceschini, Ivan
2007 Perché i sindacati cinesi non possono ‘alzare la voce’? «Mondo Cinese», n°131, aprile-giugno, (http://www.tuttocina.it/mondo_cines e/131/131_fran.htm).
Gabusi, Giuseppe
2009 L’importazione del capitalismo. Il ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico cinese, Vita&Pensiero, Milano.
2010 Pechino alle prese con la bolla immobiliare, «Affari Internazionali. Rivista on line di politica, strategia e economia», 17 giugno 2010, (http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1481).
IHLO (ITUC/GUF Hong Kong Liaison Office)
2010 A Political Economic Analysis of the Strike in Honda and the Auto Parts Industry in China, luglio (http://www.ihlo.org/LRC/W/0007 10.pdf).
Hu, Jintao
2010 Deepen Exchanges and Cooperation for Inclusive Growth, «5th APEC Human Resources Development Ministerial Meeting», Beijing, 16 settembre, (http://www.gov.cn/english/2010-09/16/contetent_ 1704109.htm).
Kurlantzick, Joshua
2010 Avoiding a Tempest in the South China Sea, Council on Foreign Relations, (http://www.cfr.org/publication/22858/avoiding_a_te pest_in_the_south_china_sea.html).
LSC «Legge sindacale cinese del 1992, emendata nel 2001»
1992 (http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=118).
Miller, Alice L.
2010 The 18th Central Committee Politburo: A Quixotic, Foolhardly, Rashly Speculative, but Nonetheless Ruthlessly Reasoned Projection, «China Leadership Monitor», n°33, giugno (http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/CLM33AM.pdf).
Ngai, Pun; Chris, King Chi Chan, Jenny Chan
2009 The Role of the State, Labour Policy and Migrant Workers’ Struggles in Globalized China, «Global Labour Journal», vol. 1, special issue in Globalization(s) and Labour in China and India, pp. 132-151.
Ngai, Pun; Lu Huilin
2010 A Culture of Violence: The Labour Subcontracting System and Collective Action by Construction Workers in Post-Socialist China, «The China Journal» n° 64, luglio, pp. 143-158;
Onnis, Barbara
2011 La Cina nelle relazioni internazionali. Dalle guerre dell’oppio a oggi, Carocci, Roma.
Pozzana, Claudia; Alessandro, Russo
2007 Il nuovo ordine cinese e i passati disordini in Oscar Marchisio (a cura di) Cina e capitalismo: un matrimonio quasi riuscito, Edizioni Sapere2000, pp. 143-176.
Russo, Alessandro
2006 How to translate ‘Cultural Revolution’, «Inter-Asia Cultural Studies», vol. 7, n° 4, pp. 673-682.
2009 Com’è finita la Rivoluzione Culturale? L’ultima disputa tra Mao Zedong e Deng Xiaoping e gli anni Settanta in Alberto, De Bernardi, Valerio Romitelli e Chiara, Cretella (a cura di) Gli anni Settanta. Tra crisi mondiale e movimenti collettivi, Archetipo, Bologna.
SACOM «Students & Scholars against Corporate Misbehaviour»
2010 Deconstructing Foxconn, «video documentario» (http://www.vimeo.com/17558439); Workers as Machines: Military Management in Foxconn, «rapporto investigativo», 12 ottobre 2010 (http://sacom .hk/wp-content/uploads/2010/11/report-on-foxconn-workers-as- machines_sacom.pdf).
Silver, Beverly
2003 Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization since 1870, Cambridge University Press, Cambridge.
Silver, Beverly; Lu Zhang
2010 Cina: epicentro emergente del conflitto operaio mondiale?, «Uninomade»,(http://uninomade.org/cina-epicentroemergente-del- conflitto-operaio-mondiale).
Tomba, Luigi
2001 Lavoro e società nella Cina popolare, Franco Angeli, Milano.
Walder, Andrew
1991 Workers, Managers and the State: The Reform Era and the Political Crisis of 1989, «The China Quarterly», n° 127, pp. 467-492.
Wang, James W.Y.
2010 The Political Economy of Collective Labour Legislation in Taiwan, «Journal of Current Chinese Affairs», vol. 39, n° 3, pp.51-85.
WB «World Bank»
2010 China Quarterly Update – November 2010 (http://www.worldbank.org/china).
Zedong, Mao
1956 Discorso alla II session plenaria dell’VIII comitato del partito comunista cinese in Maria Arena Regis e Filippo Coccia (a cura di) Rivoluzione e costruzione. Scritti e discorsi 1949-1957, Einaudi Editore, 1979.
ZRGX (Zhonghua Renmin Gongheguo Xingfa) codice penale
2000 zhongguo fazhi chubanshe, Beijing